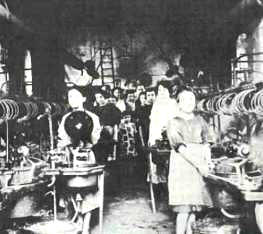|
Le teorie liberiste
Cavour ebbe pratica di testi di economia e di resoconti di riviste
economiche fin dai 18 anni. A Ginevra frequentò lezioni di Scerbouliez, a
Parigi di Pellegrino Rossi e di Michel Chevalier, a Londra prese contatto
con William Nassau senior: tutti famosi esponenti del pensiero economico
ottocentesco. Cavour, compatibilmente con gli impegni politici, dopo il 1850
rafforzò la sua cultura economica ed i suoi scritti di "economia applicata"
si legano concettualmente a molti degli assunti dei suoi discorsi
parlamentari. Le sue posizioni, di tipo liberista. L'orientamento dominante della dottrina
economica del tempo era quello del liberoscambismo o liberismo, fieramente
in lotta contro le protezioni doganali, i monopoli, i divieti ed i vincoli
statalistici. Dalla libertà degli scambi gli economisti si attendevano
decisivi incrementi del commercio e degli affari, riduzione generale dei
prezzi dei generi alimentari e delle materie prime, dei salari, dei costi di
produzione, accompagnati da generali ampliamenti delle possibilità di
consumo e da una espansione delle produzioni più convenienti a ciascun
paese con vantaggi nella specializzazione dell'offerta.
Il successo delle teorie liberiste è in
stretta relazione con l'ampiezza degli orizzonti di mercato ed alla
agevole comunicabilità fra questi, con la riduzione dei costi di trasporto.
Tali economisti sostenevano due cose:
- la prima era che la concorrenza aperta
costituiva un forte stimolo a sollecitare l'innovazione;
- la seconda
sosteneva che la libertà degli scambi avrebbe creato un'ottimale divisione
internazionale del lavoro, perché ciascun paese
avrebbe potuto massimizzare le produzioni che gli riusciva più conveniente
effettuare, data la composizione ed i costi dei fattori disponibili.
Tali teorie tuttavia spesso erano accolte
come trasgressive da un ambiente ostile come quello piemontese. Venivano infatti intese come
espressione concrete di una ideologia del progresso e della civilisation,
che non si accontentava della propaganda di utopie ma intendeva tradursi in
pratiche iniziative, affiancate da un'azione politica conseguente.
I protezionisti ripetevano vecchie teorie mercantiliste ( la ricchezza di una
nazione si realizzerebbe esportando molto e importando poco: si esprimerebbe
cioè negli avanzi di bilancia commerciale saldati in oro ),
oppure cominciavano a considerare l'industrializzazione come un imperativo
da realizzare a tutti i costi. Temevano che la divisione del lavoro potesse
produrre un vantaggio per i paesi ad economia industriale a danno dei paesi
a prevalente economia agricola.
I liberisti negavano questa
affermazione, sottolineando il carattere industriale della stessa
agricoltura moderna che poteva darsi organizzazione e capacità tecniche
innovative analoghe a quelle delle industrie manifatturiere: Cavour ad
esempio credeva che, acquisendo conoscenze e competenze avanzate avrebbe
potuto rendere elastiche e modificabili le stesse specializzazioni agrarie,
evitando "condanne fatali a produzioni meramente primarie".
Le posizioni di Cavour
Cavour non ebbe mai dubbi che le teorie
liberiste fossero le più convenienti per quella parte del territorio
italiano che cominciava a dare segni di moderna accelerazione della
crescita: l'area del futuro triangolo industriale. Egli agirà infatti nella
prospettiva di integrare il settore agricolo con quello industriale , con
quello finanziario e dei commerci, anticipando in tal senso più moderne
sinergie economiche evidenti in Italia a partire dalla seconda metà
dell'Ottocento.
Egli riteneva ad esempio che il ribasso dei prezzi cerealicoli, subito dopo
il 1830, dovuto all'arrivo in Europa dei grani ucraini attraverso i
Dardanelli, aveva in realtà provocato un generale miglioramento
dell'agricoltura anche in Italia, inducendo un mutamento in senso ottimale
delle destinazioni colturali, stimolando cioè il passaggio a produzioni più
complesse e più redditizie, come l'allevamento o la gelsobachicoltura, altre
colture legnose e colture industriali, oltre ad incentivare avvicendamenti,
adatti ad accrescere la produttività dei terreni e gli stessi rendimenti di
questi in cereali.
Una delle prime posizioni del liberismo
cavouriano fu un parere reso al ministro inglese in Piemonte, nel 1842, sui
vantaggi anche per la regione sabauda della libertà di commercio dei
cereali. Tornò sull'argomento due anni dopo richiamando l'importanza della
abolizione dei dazi sul commercio dei cereali, anticipando la decisione del
premier inglese Robert Peel del 1846 ( revoca delle Corn Laws ).
Altra
grande disputa italiana tra protezionisti e liberoscambisti aveva riguardato
divieti, vincoli, imposizioni sulle esportazioni delle sete gregge. Vietando
o ostacolando tale esportazione, se ne teneva basso il prezzo, favorendo la
loro lavorazione all'interno, nella torcitura, cioè nella produzione
intermedia del filo pronto per la tessitura. L'abolizione dei vincoli, e il
conseguente ribasso sui mercati esteri della sete gregge, ne aveva favorito
l'uso e con esso l'impiego nell'industria tessile, con conseguente
incremento della domanda mondiale non solo delle sete gregge ma anche dei
prodotti filati, fra cui quelli piemontesi.
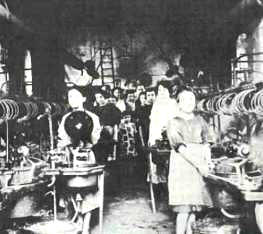
Una
filanda lombarda per la produzione del filo di seta -
da
http://www.scoprilecco.it/industrie/filande.jpg
L'interesse di Cavour per la nascita di un
nuovo sistema bancario
Tra gli affari e la politica, sta la
partecipazione di Cavour alla creazione dei primi moderni istituti di
credito a Genova e a Torino, destinati di lì a qualche anno a confluire
nella Banca Nazionale degli Stati Sardi, che più tardi divenne, com'è noto,
la Banca d'Italia. A formare nuove disponibilità monetarie doveva
contribuire una bilancia dei pagamenti che, nonostante il deficit denunciato
dai valori ufficiali della bilancia commerciale, era probabilmente attiva.
Disponibilità rilevanti di oro monetato provenivano soprattutto dalla
Lombardia, la cui bilancia commerciale nei confronti del Piemonte era
costantemente sfavorevole, in relazione specialmente ai larghi
approvvigionamenti che vi giungevano attraverso il porto di Genova.
Abbondava dunque il risparmio alla ricerca di impieghi, come è dimostrato
dall'ascesa dei corsi dei titoli pubblici.
Il grosso del credito commerciale restava
tuttavia nelle mani delle banche private, quasi sempre a carattere
strettamente familiare e spesso interessate anche in affari di commercio, le
quali, accanto ad operazioni su titoli del debito pubblico, praticavano un
ristretto credito di esercizio, scontando cambiali, concedendo anticipazioni
su depositi di merci, soprattutto seriche, ed effettuando altre operazioni a
breve termine. Esse accettavano anche depositi a custodia, emettendo perciò
moneta bancaria nella forma di titoli negoziabili e a scadenza: ma appunto
tale caratteristica differenziava la circolazione originata da queste banche
dai biglietti al portatore emessi da un moderno istituto di emissione,
convertibili a vista senza aggravio di
sconto e formalità di girate; e l'azione ne risultava dunque assai meno
conforme alle cresciute esigenze del commercio e della vita economica in
generale.
Il problema era specialmente sentito a Genova che, alle crescenti
esigenze del grande commercio d'oltremare, univa le tradizioni ancora recenti
di un grande centro finanziario e bancario a livello europeo. E appunto
gli amici e corrispondenti genovesi del Cavour, i banchieri De La Rüe, già
nella primavera del 1836 avevano sottoposto al governo il progetto di una
nuova banca, alla quale offrivano di partecipare per 600 mila franchi. Il
progetto, di cui anche Cavour aveva caldeggiato l'accettazione, era
naufragato contro le difficoltà incontrate nelle sfere di governo, nelle
quali si era persuasi che « les actions de la banque projétée ont été
accaparées par un petit nombre de capitalistes, pour la plupart étrangers,
ce qui rendrait son établissement peu populaire parmi le commerce de Génes
».
Erano preoccupazioni radicate nel paternalismo del regime assoluto, e
con esse Cavour dovrà fare i conti più volte negli anni successivi.
Tuttavia, l'iniziativa riuscì finalmente ad avere successo quando, verso la
fine del 1843, venne ripresa da un gruppo di finanzieri liguri con a capo,
ancora una volta, il duca di Galliera, che contemporaneamente sollecitava la
concessione della linea ferroviaria da Genova alla frontiera lombarda e ad
Alessandria.
A modello del nuovo istituto venne scelta
la banca fondata nel 1835 a Marsiglia, di cui si adottarono quasi alla
lettera gli statuti. Essa riceveva depositi in conto corrente senza
interessi, effettuava anticipazioni su depositi di metalli preziosi o di
cedole di Stato, e soprattutto
era autorizzata ad emettere biglietti
convertibili a vista per un ammontare pari al triplo delle sue riserve.
1.400 azioni erano riservate al soci fondatori, e per il resto 1.050 vennero
distribuite dal ministero fra altri banchieri, fabbricanti e negozianti nel
distretto di Genova, 949 in quello di Torino, 321 nel Nizzardo e 280 in
Savoia. Ne risultò un saldo predominio genovese nell'istituto, ancora
rafforzato dalle norme che regolavano la partecipazione all'assemblea degli
azionisti. Ancora prima che la Banca iniziasse la sua attività si scatenò
tuttavia una attivissima speculazione sui suoi titoli,
Fonti bibliografiche:
Rosario Romeo, Cavour e il
suo tempo, Laterza 1969 – vol. 2/1 e 2/2- Agricoltura e affari,
Storia d’ Italia , Einaudi (vol. 3) – Dal primo Settecento all’ unità. La
politica economica del Piemonte costituzionale: tributi, finanze, ferrovie
Luciano Cafagna, Cavour, Il Mulino 1999, pag. 120-128.
|