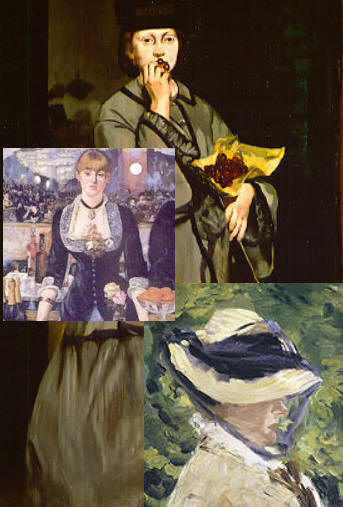
Manet - soggetti femminili

Monet, Rue Montorgueil imbandierata, 1878
Le vecchine
I
Nelle pieghe sinuose delle
vecchie capitali,
dove tutto, anche l’orrore, ha un suo incanto,
spio, fedele ai miei umori fatali,
esseri decrepiti, bizzarri e affascinanti.
Quei mostri un tempo erano donne,
Eponina o Laide! sgangherate, ingobbite,
contorte, amiamole! sono ancora anime.
Sotto lacere gonne e freddi tessuti
arrancano, flagellate da raffiche inique,
fremono al chiasso delle carrozze pubbliche
stringendo al fianco, come reliquie,
borsette a fiori o a trame enigmatiche;
trottano, in tutto simili a marionette;
a volte si trascinano come bestie ferite,
o senza volerlo ballano, povere campanelle
cui s’attacca un Demone crudele! Sfinite,
pure hanno occhi come succhielli,
lucenti come pozze dove l’acqua dorme;
hanno gli occhi divini della fanciulla
che si stupisce e ride d’ogni cosa che brilla.
- Avete notato che spesso la bara d’una vecchia
è piccola quasi come quella d’un bimbo?
È un segno d’un gusto intrigante e strambo
quello che la saggia Morte mette in siffatte bare,
e quando intravedo un fantasma gracile
attraversare il brulicante quadro di Parigi,
sempre penso che quell’essere fragile
verso una nuova culla s’incammini adagio;
a meno che, guardando quelle membra discordi
e usando la geometria, non mi metta a calcolare,
quante volte l’operaio debba cambiare
la forma della cassa che conterrà quei corpi.
- Quegli occhi son pozzi di lacrime a milioni,
crogiuoli che un metallo raffreddato screziò...
Occhi misteriosi dagli invincibili fascini
per colui che l’austera Sventura allattò!
II
Del defunto
Frascati Vestale innamorata;
sacerdotessa di Talia, di cui un suggeritore
interrato, ahimè! sa il nome; famosa svaporata
che il
Tivoli ombreggiò quand’era in fiore,
tutte m’inebriano! ma fra questi esseri fragili
c’è chi, facendo un miele del suo dolore,
ha detto alla Devozione che offriva le sue ali:
possente Ippogrifo, portami con te nell’etere!
L’una addestrata alla sventura dalla sua patria,
l’altra, oppressa di dolori dal marito,
l’altra ancora, Madonna trafitta dal figlio,
avrebbero fatto un fiume con il loro pianto!
III
Di queste vecchine quante ne ho seguite!
una, fra le altre, nell’ora in cui il sole declina
straziando il cielo di vermiglie ferite,
in disparte, pensosa, su una panchina,
ascoltava una di quelle sonore fanfare
di cui i soldati a volte inondano i giardini,
e che, nelle sere d’oro in cui ci si sente ravvivare,
versano un po’ d’eroismo nel cuore dei cittadini.
Ancora diritta, fiera e seguendo il ritmo,
assorbiva avida quel canto vivo e guerriero;
talvolta apriva l’occhio come una vecchia aquila;
la sua fronte di marmo sembrava fatta per l’alloro!
IV
Così, stoiche e senza lamenti, ve ne andate
attraverso il caos delle città eccitate,
madri dal cuore trafitto, sante o baldracche,
il cui nome un tempo era su tutte le bocche.
Ora nessuno vi riconosce, voi che foste
la grazia e la gloria! un rude ubriacone
passando v’irride con amorose proposte;
dietro di voi saltella un piccolo mascalzone.
Vergognose d’esistere, ombre rattratte,
timorose, la schiena curva e rasente i muri;
nessuno più vi saluta, strani destini!
Rottami d’umanità per l’eterno maturi!
Ma io, che da lontano teneramente sorveglio,
inquieto, il vostro incerto cammino,
come se fossi vostro padre, o meraviglia!
a vostra insaputa gusto un piacere clandestino:
vedo sbocciare le vostre passioni novizie;
vivo, cupi o raggianti, i vostri giorni perduti;
il mio cuore moltiplicato gode ogni vostro vizio!
Il mio spirito risplende d’ogni vostra virtù!
Rovine! mia famiglia! o cervelli congeneri!
io vi do ogni sera un solenne addio!
dove sarete domani, Eve ottuagenarie,
su cui pesa il tremendo artiglio di Dio?
Voltando le
spalle al mondo della natura ( che non popola stabilmente l'immaginario
poetico di Baudelaire ) il poeta incontra la città, la Parigi delle
ristrutturazioni di Haussmann, che la fanno diventare una città moderna, a
tratti irriconoscibile. Un numero considerevole di composizioni dei
Fiori del male hanno come tema la città: la raccolta presenta
l'intera sezione Tableaux parisiens ( Quadri
parigini ) imperniata sul rapporto tra la città e il poeta.
E' Parigi con i suoi originali emblemi di vita, malamente ancorati ai
paesaggi della modernità, che ci fa intuire a quali aspetti della vita
urbana Baudelaire si interessi. Non si rivolge tanto a ciò che la città
mostra, ma a quanto essa è intenta a celare scrupolosamente ( miseria,
degrado, bassezza morale, prostituzione ). Parigi è rivissuta in modo
contraddittorio nelle menti e nei cuori di soggetti apparentemente
marginali, rigorosamente recuperati dalla poesia come preziosi emblemi di
vita. Le vecchine,
i ciechi, la
passante sono altrettanti elementi di questo indistinto e
brulicante consorzio umano, che la città include nelle sue strutture urbane,
ormai disumanizzanti.
L'attenzione del poeta per questi soggetti è spontanea, non
semplicemente curiosa: essi
incarnano - un po' misteriosamente - la tensione verso
l'amore, il rifiuto della piattezza quotidiana del vivere, la costante
interrogazione sul senso delle cose. E Baudelaire li osserva, li scruta
amorosamente, li ama, li canta come i veri interpreti dell'unica bellezza
che la città sa riservare al poeta.
" Baudelaire pare non dimenticare mai la comunità degli uomini.
Essa si trova sempre là, nella sua indistinta totalità - mentre "un'oscura
atmosfera avviluppa la città" - e gli esseri si differenziano, pur
restando parte di un'anonima collettività. Anche se "agli
uni <la città> porta la pace, agli altri pensieri e turbamenti".
Una certa forma di solidarietà agisce al di sopra degli individui,
attraversando le masse anonime. Così i ciechi possono passare senza
sapere che il poeta è legato a loro da una comune inquietudine metafisica:
questa solidarietà non di meno è effettiva. Baudelaire ha avuto l'acuto
sentimento di tale implicita forma di solidarietà e di relazionalità che
accomuna - seppur fragilmente - gli abitanti della città. Esprime il
concetto esplicitamente nella poesia A una
passante. Due esseri si incrociano, non si rivedranno più, se non
nell'eternità. Due destini si incontrano per un momento, anonimi ma non del
tutto indipendenti l'uno dall'altro ( Poichè non so dove fuggi, tu non sai dove vado,/
o tu che avrei amata, o tu che l'hai saputo! )
da G.Bonneville "Les fleurs du mal" - Profil d'une œuvre -
Hatier pp.38-39

Bonnard - Une passante

Pissarro - Il Boulevard Montmartre, 1897
La via assordante attorno a me urlava.
Alta, sottile, in lutto, dolore maestoso
una donna passò con la mano fastosa
sollevando orlo e balza, facendoli oscillare;
agile e aristocratica, con la sua gamba di statua.
Io, io contratto come un maniaco, bevevo
dai suoi occhi, cielo livido gonfio di bufera,
la dolcezza che affascina e il piacere mortale.
Un lampo... poi la notte! -
Fuggitiva beltà
il cui sguardo in un attimo mi ha risuscitato,
ti rivedrò soltanto nell'eternità?
Lontano, chissà dove! troppo tardi! forse mai più!
Poiché non so dove fuggi, tu non sai dove vado,
o tu che avrei amata, o tu che l'hai saputo!
Alcune poesie affrontano il particolare rapporto tra
l'artista, la sua attività creativa ( la poesia ) e la città. A livello
simbolico Parigi diviene la prigione da cui bisogna evadere con
l'immaginazione poetica, che è sempre atto di elevazione dal basso, dal
fermo e condizionato universo delle cose.
L'albatros e
Il cigno sono le
metafore che esprimono il bisogno di distacco fisico dalla bassezza
dell'universo umano, in uno slancio verticale, ideale verso la purezza del
cielo della creazione. Ma le due composizioni sono
accomunate anche dal persistere dei vincoli che negano questa liberazione; o
perlomeno dalla definizione del disagio a misurarsi con gli uomini
della nuova città, insensibili all'arte,
che popolano Parigi, ormai segnata dal progresso industriale, dove il
cigno non ritrova più il suo bel lago natale ma solo un secco
rivolo, mentre bagna le sue ali nella polvere. Queste immagini
restituiscono tutta la fisicità del disagio a convivere con una città,
dove la folla fa sentire ancor più solo il poeta, dove la solitudine
del resto è cercata come unico modo per ricrearsi un vero spazio
creativo. In Paesaggio Parigi è vista
dall'alto di una soffitta, come essenza lontana, decantata delle sue
impurità, idealmente rinata a fonte di ispirazione. La città del
lavoro e dei fumi si trasforma magicamente nell'immaginario poetico ,
diviene paesaggio evanescente che permette di ribaltare facilmente
i suoi ritmi monotoni con quelli della natura, facendo sognare
primavere, estati ed autunni favolosi.
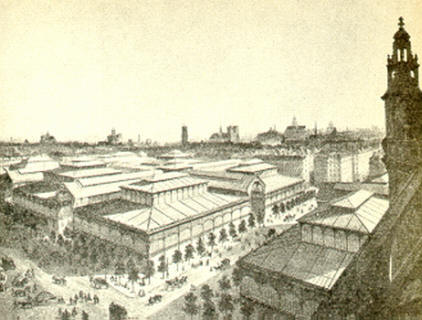
Les Halles di Parigi

Panorama de l'île de la Cité

Léon Spilliaert - Cigni

Séebeerger - Montmartre a Parigi
I
Andromaca, è a te che penso! Quel fiume,
misero e triste specchio ove un tempo brillò
l’immensa maestà della tua pena di vedova,
quel falso
Simoenta che il tuo pianto ingrossò,
d’un tratto ha fecondato la mia
memoria ferace,
mentre attraversavo il nuovo
Carrousel.
La vecchia Parigi è scomparsa (ahimè, più veloce
d’un cuore cambia l’aspetto d’una città);
solo in spirito vedo quel campo di baracche,
erbe, blocchi inverditi da acque stagnanti,
capitelli appena sbozzati e colonne a mucchi,
e confuse cianfrusaglie in vetrine luccicanti.
Là c’era un serraglio; là un mattino,
nell’ora in cui il Lavoro si ridesta
e sotto un freddo e chiaro cielo lo spazzino,
nell’aria silente, alza una cupa tempesta,
vidi un cigno fuggito dalla sua gabbia;
sfregando con i piedi palmati l’arido selciato,
trascinava le bianche piume sul suolo accidentato.
Presso un secco rivolo la bestia, aprendo il becco,
bagnava nervosamente le ali nella polvere,
e diceva, il cuore colmo del suo bel lago natale:
«Acqua, quando scenderai?
Quando tuonerai, folgore?»
Rivedo quell’infelice, mito strano e fatale,
tendere la sua testa sul collo agitato,
talvolta verso il cielo, come
l’uomo d’Ovidio,
verso il cielo ironico, d’un azzurro spietato,
come a rivolgere il suo rimprovero a Dio!
II
Parigi cambia! Ma niente nella mia malinconia
s’è mosso! blocchi, impalcature, nuovi palazzi,
vecchi sobborghi, tutto per me diventa allegoria,
e i miei cari ricordi son più grevi dei macigni.
Così davanti a questo Louvre una visione m’opprime:
penso al mio grande cigno, ai suoi folli gesti,
che, come un esule, lo rendeva ridicolo, sublime,
divorato da un desiderio eterno! e penso a te,
Andromaca, come vile animale strappata
a un grande sposo e piegata al superbo Pirro,
curva nell’estasi sopra una tomba vuota;
vedova d’Ettore, ahimè! e moglie d’Eleno!
Penso alla negra, smagrita e tisica,
che, con l’occhio torvo e i piedi nella melma,
cerca le palme assenti della maestosa Africa
dietro il muro immenso della bruma;
a chiunque ha perduto ciò che mai si ritrova,
mai, mai più! e s’abbevera con i suoi pianti
e succhia il Dolore come una buona lupa!
ai magri orfanelli simili a fiori appassiti!
Così nella foresta il mio spirito s’esilia,
un antico Ricordo suona il corno con forza!
Penso ai marinai dimenticati su un’isola,
ai prigionieri, ai vinti!... e a molti altri ancora!
È con Hölderlin che il cigno, inteso come metafora della poesia, non riesce
più a svolgere la propria funzione (o le proprie funzioni):con la crisi
dell’idealismo tedesco, o meglio, si potrebbe dire dell’idealismo
occidentale, la poesia appare irrimediabilmente inconciliabile. Una delle
poesie più famose di Hölderlin tra le più difficili di tutta la
letteratura tedesca, intitolata Hälfte des Lebens, il poeta svevo
esprime l’isolamento del poeta-cigno e la volontà di annullamento
dell’estetica romantica. Con Hälfte des Lebens l’identificazione
metaforica dei cigni con l’esistenza del poeta si realizza come perdita del
centro, come allontanamento definitivo del poeta (cigno tra i cigni) da una
condizione originaria di vita armoniosa e conciliata con la natura, in cui
dominano felicità e perfezione.
Charles Baudelaire (Le Cygne, 1860 ) si assume il compito di
trasportare il cigno sull’asfalto della metropoli. L’animale cammina
lentamente, in modo goffo e grottesco, su un terreno inadatto e non liquido:
«le pavé sec». Il soggetto poetico moderno si trova così efficacemente
rappresentato da Baudelaire nella sua dimensione orizzontale e
metropolitana. Il cigno infatti non possiede più la
capacità di volare né può in alcun modo ambire ad alcuna forma di
verticalizzazione: esso appare del tutto prigioniero dello spazio urbano. Il
povero animale non è più legato, neppure dal ricordo di un volo icarico, a
spazi non terrestri come cielo ed acqua. Si aggira prigioniero e mercificato
(«évadé de son cage») nello spazio della metropoli moderna nella sua
incommensurabilità ed anonimità. Il cigno di Baudelaire ci appare come una
visione traumatica che allude all’ingresso del soggetto poetico nella
modernità con tutto il suo carico di malinconia. Il centro è ormai un
conglomerato urbano instabile e privo di forme definitive, in cui dominano
alienazione, schiavitù e reificazione. Il soggetto
poetico (lo spirito, l’immaginazione lirica) può sopravvivere solo come
antinomia al mondo materializzato e reificat
da http://www.dllc.unicas.it/riviste/Trame/trame_vol2/bontempelli2.pdf
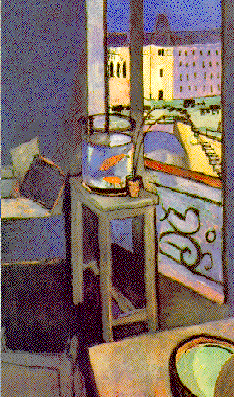
Matisse - Vaso con pesci rossi

Puvis de Chavannes, L'estate, 1873
Voglio, per comporre in castità le mie egloghe,
dormire accanto al cielo, come gli astrologhi,
e, vicino alle campane, ascoltare sognante
i loro inni solenni portati dal vento.
Dall’alto della soffitta, le mani sotto il mento,
vedrò l’officina che chiacchiera e canta;
i comignoli e i campanili, alberi di città,
e grandi cieli che fanno sognare d’eternità.
Com’è dolce veder nascere tra le brume
la stella nell’azzurro, alla finestra il lume,
i fiumi di carbone salire al firmamento
e la luna versare il suo vago incantamento.
Vedrò le primavere, le estati, gli autunni
e quando verrà l’inverno e le sue monotone nevi,
dappertutto chiuderò tende e imposte,
per costruire nella notte i miei palazzi fatati.
Mi abbandonerò al sogno di orizzonti bluastri,
di giardini, di zampilli piangenti in alabastri,
di baci, d’uccelli che cantano mattino e sera,
e tutto quello che di più infantile c’è nell’Idillio.
La Sommossa, battendo invano sul vetro,
non riuscirà a farmi alzare la fronte dal leggìo;
perché sarò immerso in quella voluttà
di evocare la Primavera con la mia volontà,
di tirar fuori un sole dal mio cuore e di fare
dei miei ardenti pensieri un tiepido aere.