|
La nuova poesia
popolare o la poesia dei vivi.
"...Di mano in mano che le nazioni europee si riscuotevano dal sonno
e dall'avvilimento, di che le aveva tutte ingombrate la irruzione dei
barbari dopo la caduta dell'impero romano, poeti
qua e là emergevano a ringentilirle.
Compagna volontaria del pensiero e figlia ardente delle passioni, l'arte
della poesia, come la fenice, era riuscita di per sè in Europa, e di per
sè anche sarebbe giunta al colmo della perfezione. (...)
i Trovatori, né da Pindaro istruiti né da Orazio, correndo all'arpa,
prorompevano in cantici
spontanei ed intimavano all'anima del popolo il sentimento del bello. (...)
Avviata così nelle nazioni la tendenza poetica, crebbe nei poeti il
desiderio di lusingarla più degnamente.(...) Ma, ad onta degli studi e
dell'erudizione, i
poeti che dal risorgimento delle lettere più fino ai giorni nostri
illustrarono l'Europa, e che portano il nome comune di moderni, tennero
strade diverse. (...) Interrogarono
direttamente la natura:
e la natura non dettò loro né pensieri né affetti antichi, ma
sentimenti e massime moderne. Interrogarono
la credenza del popolo e n'ebbero in risposta i misteri della religione
cristiana.
Interrogarono l'animo umano e quello non disse loro che cose sentite da
loro stessi e da loro contemporanei..... "
Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, 1816
|
|
L'attività poetica rinasce in modi nuovi nell'età che vede imporsi sul
clima repressivo della Restaurazione il fervore della coscienza dei nuovi
popoli europei . L'idea di
nazione
trae ispirazione dalle
antiche tradizioni medioevali,
che valorizzano le singole etnie, e dalla tradizione cristiana,
che riflette una rinascente
spiritualità popolare a scapito dei modelli classici, universalmente
accettati fino ad ora come esempi di perfezione formale inimitabile. Il
nuovo sentimento poetico contrassegna un pubblico nuovo, più ampio ed ha
una valenza fortemente ideale e politica, in quanto si accompagna allo
spirito di libertà che attraversa le società del primo Ottocento.
La poesia dei
moderni è per
Berchet data dall'insieme
eterogeneo di atteggiamenti creativi,
che si rivolgono con spirito integro alle forze della natura, ai misteri
della religione ed ai fatti della storia dei popoli,
attualizzando
valori e situazioni, al fine di ridestare la profonda sensibilità
artistica, potenzialmente operante nella coscienza di vasti strati
popolari. In tal senso appare indispensabile conoscere le forme di
produzione letteraria che l'intera Europa produce: di qui
il valore insostituibile delle
traduzioni.
|
|
L'abbandono
dei modelli classici per una poesia vera, interessante e utile.
Dove poi l'opinioni de' Romantici erano unanimi, m'è parso, e mi pare,
che fosse in questo: che la poesia deva proporsi per oggetto il
vero come l'unica sorgente d'un diletto nobile e durevole;
giacché il falso può bensì trastullar la mente, ma non arricchirla, né
elevarla; e questo trastullo medesimo è, di sua natura instabile e
temporario, potendo essere, come è desiderabile che sia, distrutto, anzi
cambiato in fastidio, o da una cognizione sopravvegnente del vero, o da un
amore cresciuto del vero medesimo. Come il mezzo più naturale di render
più facili e più estesi tali effetti della poesia, volevano che essa
deva scegliere de' soggetti che, avendo quanto è necessario per interessare
le persone più dotte, siano insieme di quelli per i quali un maggior
numero di lettori abbia una disposizione di curiosità e
d'interessamento, nata dalle memorie e dalle impressioni giornaliere
della vita; e
chiedevano, per conseguenza, che si desse finalmente il riposo a quegli
altri soggetti, per i quali la classe sola de' letterati, e non tutta,
aveva un'affezione venuta da abitudini scolastiche, e un'altra parte del
pubblico, non letterata né illetterata, una reverenza, non sentita, ma ciecamente
ricevuta.
A.
Manzoni, Lettera sul Romanticismo |
|

F.Hayez, I vespri siciliani, 1827
|
|
L'argomento del quadro fa riferimento alla sollevazione avvenuta a
Palermo il 30 marzo 1282 contro l'oppressione del potere angioino
nell'Italia meridionale. All'uscita dalla funzione religiosa vespertina
una donna palermitana è stta oltraggiata da un francese.Immediata la
reazione:l'oltraggiatore è ferito a morte da un giovane.
I protagonisti come i cantanti di un melodramma, sono in primo piano: la
donna in deliquio, sostenuta dal fratello, il francese cadente con la
mano appoggiata sulla ferita, il giovane con la punta della spada ancora
intrisa di sangue si ritira. Intorno c'è il coro, il popolo, pronto a
riconquistare coscienza di sé nella rivolta prossima a scoppiare
|
|
La poetica manzoniana si regge sui tre elementi fondamentali del
vero come soggetto,
dell'interessante come mezzo e dell'utile come scopo. La
ricostruzione del fatto storico poggia dunque sulla
rappresentazione
attualizzata del passato, che
deve interessare un pubblico vasto con la forza e la pregnanza delle
realtà rappresentate, ma anche avere un'utilità
morale, costituendo un' utile
guida all'azione nel presente.
|
|
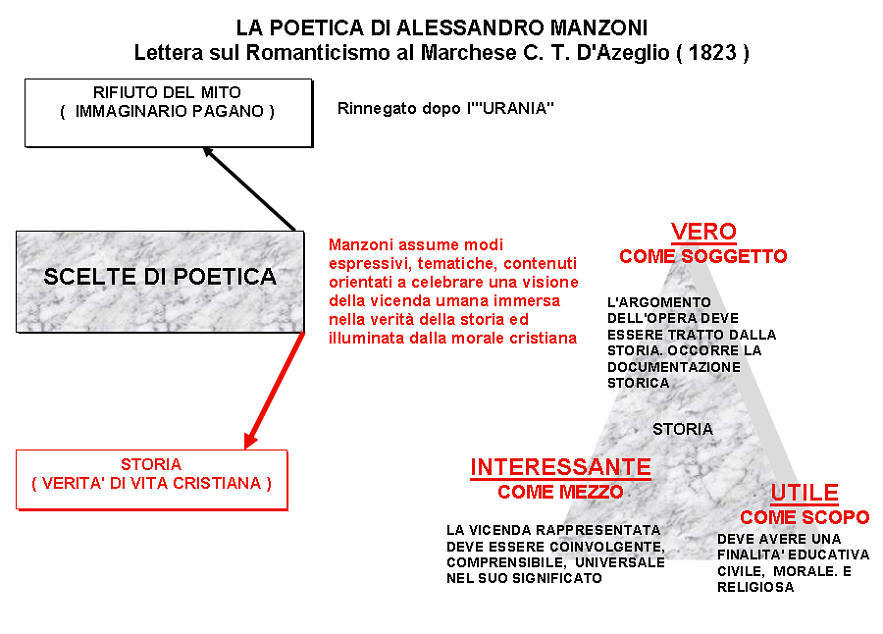 |
|
Ogni soggetto artistico
rievoca dunque precisi
eventi storici. Si
opera una ricostruzione
quasi teatrale delle sequenze centrali delle vicende.
I personaggi sono fortemente contestualizzati ( presentati in modo che
possano essere chiaramente ricondotti al loro tempo attraverso
l'ambientazione, le architetture, i costumi, le armi.. ). Dunque la
rappresentazione storica è frutto di
documentazione.
I temi centrali sono tuttavia anche
ricontestualizzati,
cioè presentati come
fortemente attuali nel loro valore simbolico.
E' auspicabile, nella condizione di asservimento dell'Italia
prerisorgimentale, ritrovare con la medesima energia lo spirito di
sacrificio degli eroi di cui la storia medioevale e rinascimentale è
ricca.
Quest'arte è popolare
in quanto si ricollega ed esprime
sentimenti diffusi nel popolo.
E' educativa
in quanto propone e trasmette ideali , valori
morali e civili, chiari e facilmente condivisibili.
|

