Ambientato nei mesi della Resistenza, tra i vicoli di una città ligure della
Riviera di Ponente ed i boschi e le valli in cui si svolge la
guerra partigiana, Il sentiero dei nidi di
ragno racconta la storia di Pin, un bambino
solo e desideroso di appartenere al mondo degli adulti
dei vicolo e dell'osteria, dai quali cerca di farsi accettare.
Insultato per le relazioni che la sorella intrattiene con i militari
tedeschi e sfidato a provare la sua fedeltà, Pin
sottrae all'amante della donna una pistola e la nasconde in campagna, nel
luogo in cui è solito rifugiarsi, ove i ragni fanno il nido.
L'azione mette in moto una sequenza d'eventi che lo portano ad
entrare in contatto con quel mondo degli adulti che
gli sembrava misterioso: è arrestato dai tedeschi; conosce un giovane
partigiano, Lupo Rosso, con il quale evade dalla prigione; fugge nei boschi
e incontra la banda partigiana del Dritto, composta di personaggi
dubbi e poco eroici. Fra essi è un ragazzo, Pelle, che ruba la pistola a
Pin. Alla fine Pelle viene ucciso, la banda è sciolta e
Pin rientra in possesso dell'arma; la presta
poi ad un partigiano, il Cugino, che la userà, forse, per giustiziare la
sorella.
tratto da Le letteratura Italiana Einaudi, vol X ( edizione multimediale )
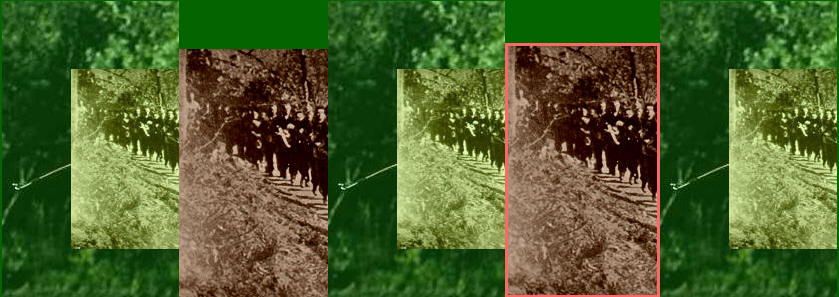
Calvino, nell'importante prefazione all'opera, ricostruisce il
clima culturale degli anni del secondo dopoguerra,
che diedero vita alla produzione neorealista.
Il secondo conflitto mondiale, concluso con il periodo
resistenziale ( 1943 - 1945 ) fu percepito dagli intellettuali come
particolarmente significativo per le sorti della società italiana.
La necessità di raccontare le vicende belliche
fu subito sentita da tutti gli scrittori, impegnati e non, in quanto in quei
racconti sembravano rivivere valori forti di una
società altrimenti senza storia ed identità. Tuttavia Calvino ammette
che allo sforzo di comunicazione non corrisposero risultati soddisfacenti;
anche l'interpretazione favolistica che egli diede di
quella lotta, guardata attraverso gli occhi del bambino Pin, riusciva appena
a dare il senso drammatico degli eventi. All'origine orale di molte
di queste storie è riconducibile l'enfasi con cui vengono presentati i fatti
epici, avventurosi, tragici, talvolta crudeli legati agli episodi della
lotta partigiana. Calvino dice che "alcune
pagine del romanzo hanno all'origine questa tradizione orale appena nata,
nei fatti e nel linguaggio". C'è nelle opere
del periodo neorealista "...la
voglia di esprimere Esprimere che cosa? Noi
stessi, il sapore aspro della vita che avevamo appreso allora allora, tante
cose che si credeva di sapere o di essere, e forse veramente in quel momento
sapevamo ed eravamo."
La guerra e la lotta partigiana, recuperate
dalla letteratura neorealista, furono poi un'occasione per
dar voce alle molte Italie popolari "
sconosciute l'un l'altra ...." con "...la
loro varietà dei dialetti e dei gerghi". "...La caratterizzazione locale
voleva dare sapore di verità a una rappresentazione in cui doveva
riconoscersi tutto un vasto mondo....".
E non solo; essa fu anche un'occasione per molti
scrittori per riappropriarsi in modo
significativo del loro paesaggio, della
loro terra, sentita come violata, ferita dalla guerra e poi rinata a
vita nuova nell'eroica epopea della lotta per la sua liberazione.
"La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio
e persone"
dice Calvino nella prefazione al Sentiero dei nidi di ragno.
La natura, in effetti, assume significati non puramente contestuali,
di sfondo all'azione, ma si fa protagonista essa stessa, si fa magica,
imprevedibile nicchia di fantastiche perlustrazioni e di esclusivi
nascondigli. Attraverso gli occhi del personaggio Pin
la guerra diventa un'avventura come un'altra, che viene vissuta
dolorosamente sopratutto per la devastazione di quel che resta degli affetti
familiari ( il tradimento e la prostituzione della sorella )
e per la fine dell'integrità della natura (
devastata da Pelle nel momento in cui si impossessa della pistola, nascosta
nel sentiero dei nidi di ragno). Proprio attraverso di Pin custode di
quella pistola, emblema ambiguo, non più giocattolo ma simbolo di potere
e di morte, quasi taumaturgico oggetto - magico che sanziona la sua
iniziazione alla vita adulta, Calvino decide di riparlarci - con
amara ironia - della fine del secondo conflitto mondiale e delle bande
partigiane che agirono nell'entroterra ligure. Dunque, al di là dei proclami
sul valore etico ed artistico della stagione neorealista, leggiamo in questo
tentativo di introdurre un elemento favoloso nella
presentazione dei tragici eventi del periodo resistenziale, un rifiuto
della retorica partigiana, ed al contrario una personalissima
rappresentazione degli effetti disumanizzanti della storia.
Prefazione all'edizione del 1964
Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire
la prima cosa che ho scritto, se si eccettuano pochi racconti. Che
impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? Più che come un'opera mia
lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale d'un'epoca, da
una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra
generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
L'esplosione letteraria di quegli anni in Italia, fu prima che un fatto
d'arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la
guerra, e noi più giovani - che avevamo fatto appena in tempo a fare il
partigiano - non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», ma
vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa,
depositari esclusivi d'una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o
gratuita euforia; tutt'altro: quello di cui ci sentivamo depositari era
un
senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero, un rovello
problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo
sbaraglio; ma l'accento che vi mettevamo era quello d'una
spavalda
allegria. Molte cose non nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei
primi racconti e del primo romanzo.
Questo ci
tocca oggi, soprattutto: la voce anonima dell'epoca, più forte delle nostre
inflessioni individuali ancora incerte. L'essere usciti da un'esperienza
guerra, guerra civile - che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva
un'immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era
faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva
avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose,
ci si strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare fu per la
gente,al principio smania di raccontare: nei treni che riprendevano a
funzionare, gremiti di persone e pacchi di farina e bidoni d'olio, ogni
passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano
occorse, e così ogni avventore ai tavoli delle «mense del popolo», ogni
donna nelle code ai negozi - il grigiore delle vite quotidiane sembrava cosa
d'altre epoche; ci muovevamo in'un multicolore universo di storie.
Chi cominciò a scrivere allora si trovò così a trattare la medesima materia dell'anonimo narratore orale: alle storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati spettatori s'aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti, con una voce, una cadenza, una espressione mimica. Durante la guerra partigiana le storie appena vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie raccontate la notte attorno al fuoco, acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come di bravata, una ricerca d'effetti angosciosi o truculenti. Alcuni miei racconti, alcune pagine di questo romanzo hanno all'origine questa tradizione orale appena nata, nei fatti, nel linguaggio.
Eppure, eppure, il segreto di come si scriveva allora non era soltanto in questa elementare universalità dei contenuti, non era lì la molla ( forse l'aver cominciato questa prefazione rievocando uno stato d'animo collettivo, mi fa dimenticare che sto parlando di un libro, roba scritta, righe di parole sulla pagina bianca ); al contrario, mai fu tanto chiaro che le storie che si raccontavano erano materiale grezzo: la carica esplosiva di libertà che animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare o informare, quanto in quella di esprimere. Esprimere che cosa? Noi stessi, il sapore aspro della vita che avevamo appreso allora allora, tante cose che si credeva di sapere o di essere, e forse veramente in quel momento sapevamo ed eravamo. Personaggi, paesaggi, spari, didascalie politiche, voci gergali, parolacce lirismi, armi ed amplessi non erano che colori della tavolozza, note del pentagramma, sapevamo fin troppo bene che quel che contava era la musica e non il libretto, mai si videro formalisti così accaniti come quei contenutisti che eravamo, mai lirici così effusivi come quegli oggettivi che passavamo per essere.
Il «neorealismo» per noi che cominciammo di li, fu quello; e delle sue qualità e difetti questo libro costituisce un catalogo rappresentativo, nato com'è da quella acerba volontà di far letteratura che era proprio della «scuola». Perché chi oggi ricorda il «neorealismo» soprattutto come una contaminazione o coartazione subita dalla letteratura da parte di ragioni extraletterarie, sposta i termini della questione: in realtà gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e indiscutibili che parevano un dato di natura; tutto il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in opera letteraria quel mondo che era per noi il mondo.
Il «neorealismo» non fu una scuola. (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, anche - o specialmente - delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. Senza la varietà di Italie sconosciute l'una all'altra - o che si supponevano sconosciute -, senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato «neorealismo». Ma non fu paesano nel senso del verismo regionale ottocentesco. La caratterizzazione locale voleva dare sapore di verità a una rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto un vasto mondo: come la provincia americana in quegli scrittori degli Anni Trenta, di cui tanti critici ci rimproverano d'essere gli allievi diretti o indiretti. Perciò il linguaggio, lo stile, il ritmo avevano tanta importanza per noi, per questo nostro realismo che doveva essere il più possibile distante dal naturalismo. Ci eravamo fatta una linea, ossia una specie di triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno sulla base del proprio lessico locale e del proprio paesaggio. (Continuo a parlare al plurale, come se alludessi a un movimento organizzato e cosciente, anche ora che sto spiegando che era proprio il contrario. Come è facile, parlando di letteratura, anche nel mezzo del discorso più serio, più fondato sui fatti, passare inavvertitamente a contar storie... Per questo, i discorsi sulla letteratura mi danno sempre più fastidio, quelli degli altri come i miei).
Il mio paesaggio era qualcosa di gelosamente mio (è di qui che potrei cominciare la prefazione: riducendo al minimo il cappello di «autobiografia d'una generazione letteraria», entrando subito a parlare di quel che mi riguarda direttamente, forse potrò evitare la genericità, l'approssimazione ... ), un paesaggio che nessuno aveva mai scritto davvero (Tranne Montale, - sebbene egli fosse dell'altra Riviera, Montale che mi pareva di poter leggere quasi sempre in chiave di memoria locale, nelle immagini e nel lessico). lo ero della Riviera di Ponente; dal paesaggio della mia città - San Remo - cancellavo polemicamente tutto il litorale turistico lungomare con palmizi, casinò, alberghi, ville - quasi vergognandomene; cominciavo dai vicoli della Città vecchia, risalivo per i torrenti, scansavo i geometrici campi di garofani, preferivo le «fasce» di vigna e d'oliveto coi vecchi muri a secco sconnessi, m'inoltravo per le mulattiere sopra i dossi gerbidi, fin su dove cominciano i boschi di pini, poi i castagni, e cosi ero passato dal mare - sempre visto dall'alto, una striscia tra due quinte di verde - alle valli tortuose delle Prealpi liguri.
Avevo un paesaggio. Ma per poterlo rappresentare occorreva che esso diventasse secondario rispetto a qualcos'altro: a delle persone, a delle storie. La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone. Il romanzo che altrimenti mai sarei riuscito a scrivere, è qui. Lo scenario quotidiano di tutta la mia vita era diventato interamente straordinario e romanzesco: una storia sola si sdipanava dai bui archivolti della Città vecchia fin su ai boschi; era l'inseguirsi e il nascondersi d'uomini armati; anche le ville, riuscivo a rappresentare, ora che le avevo viste requisite e trasformate in corpi di guardia e prigioni; anche i campi di garofani, da quando erano diventati terreni allo scoperto, pericolosi da attraversare, evocanti uno sgranare di raffiche nell'aria. Fu da questa possibilità di situare storie umane nei paesaggi che il «neorealismo ( trasse origine )" ...
Analisi e commento liberamente rielaborati
dalla pagina web:
http://www.italialibri.net/opere/sentierodeinididiragno.html
Calvino scrisse Il sentiero dei nidi di ragno nel 1946, subito dopo
il periodo della Resistenza, culturalmente connotato «prima che un fatto
d’arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo», connotato dal
desiderio di dire, raccontare, illustrare gli anni dello scontro
civile, della paura, della morte e anche del disinganno legato alla lotta
partigiana. Una desiderio così forte da sopraffare anche la volontà
artistica dei singoli autori, il loro stile, le scelte narrative,
tanto che ciò che rimane di quegli anni è soprattutto «la voce
anonima dell’epoca, più forte delle nostre inflessioni individuali ancora
incerte», perché «la carica esplosiva di libertà che
animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare
e informare, quanto in quella di esprimere» (dalla Prefazione
all’edizione 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno). Il prorompente
prevalere della vita sull’arte, insomma.
Una singolare caratteristica rende Il sentiero dei nidi di ragno un romanzo particolare, quasi unico nella tradizione letteraria italiana. È la prospettiva, la focalizzazione dal basso della vicenda: la guerra è raccontata attraverso lo sguardo trasognato e dispettoso di un bambino, che vede il mondo con assoluta esattezza, isolandone i particolari con oggettività, perché non possiede ancora gli strumenti etici con cui gli adulti distinguono il bene dal male. Calvino ha volontariamente scelto questa prospettiva particolare, da cui osservare di scorcio i movimenti tumultuosi e a volte incomprensibili della recente storia: lo scrittore dà voce ad un protagonista che rappresenta «un’immagine di regressione» in cui la storia viene filtrata dallo sguardo spietato ed indifeso di un bambino. Pin osserva dal suo mondo fiabesco di «bambino vecchio» le esistenze misteriose e ingarbugliate dei grandi: e a volte sono gli amplessi animaleschi della sorella, che Pin spia con «occhi come punte di spillo» dal ripostiglio stretto e scuro che è la sua camera, a volte sono parole oscure e affascinanti (GAP, troschista, STEN, SIM) alle quali il bambino attribuisce significati favolosi, a volte è l’umanità storta e rabberciata del distaccamento del Dritto. E tutto questo è la Storia, ma Pin non lo sa, non sa ancora cosa sia la storia, quest’oggetto incomprensibile che nei suoi sogni di bambino prende la forma di una pistola, una P38 rubata ad un ufficiale tedesco, uno degli amanti di sua sorella. La pistola diventa allora l’oggetto magico delle favole, è l’anello che rende invisibili, la bacchetta magica che permette a Pin di entrare nel mondo favoloso dei grandi.
Pin è un personaggio di confine, sospeso tra un’infanzia che non gli è mai appartenuta e un mondo adulto ancora lontano ed estraneo, ma che tuttavia lo attrae, perché sente che lì forse potrà avere un’occasione di riscatto, potrà trovare l’Amico, il compagno, l’anima con cui condividere il castello di sogni e segreti su cui poggia la sua piccola vita senza affetti. In questa sua ricerca sconclusionata, senza guide e senza direzioni preordinate, Pin a volte guarda gli adulti con i suoi occhi vuoti di esperienza, e da questa osservazione sa trarre una saggezza tutta sua, che lo rende ancora più solo, ancora più in bilico tra desiderio, rabbia e paura.
L’unico gioco a contare in questo momento è la guerra, e anche Pin vuole parteciparvi, con la cieca cocciutaggine del bimbo che non vuole rimanere da solo nell’angolo del cortile, che vuole anche lui far parte della banda. Ma è un gioco duro e difficile, e le regole molto spesso sfuggono a Pin: non capisce i comportamenti e le reazioni di questi uomini, un po’ delinquenti un po’ clown, che si trovano, riuniti in un bosco come i personaggi di una fiaba dei Grimm, a recitare il dramma della Storia ognuno a modo suo, senza che ci sia un regista a dare un senso al tutto. Anche Pin prova a ritagliarsi un suo ruolo, nel modo che conosce meglio: quello del monello beffardo, senza vergogna, senza peli sulla lingua, che con i suoi scherzi spazza via e maschere e le ipocrisie degli adulti.
Ma anche la sua è una maschera, anche Pin ha un vuoto, un dolore segreto da nascondere. Sotto la scorza di scugnizzo buffo e vivace, il desiderio profondo è la pace, la purezza, quelle che la Storia non può né potrà mai dare e che allora Pin cerca nella natura, lontano dal «contagio del peloso e ambiguo carnaio del genere umano». È una natura russoviana, libera, selvatica e incontaminata. Il mondo immobile e incantato del sentiero dei nidi di ragno, che solo Pin conosce, e che rivelerà solo al suo grande Amico, quando finalmente lo incontrerà. Ma nel frattempo, il bambino trasporta anche lì il suo bagaglio di sofferenze e crudeltà, e da vittima dei grandi si trasforma in carnefice delle creature di fossi e prati. «Chissà che cosa succederebbe a sparare a una rana», si domanda, «forse resterebbe solo una bava verde schizzata su qualche pietra»; e poi infilza i ragni su lunghi stecchi per osservarli con gelida attenzione, «un piccolo ragno nero, con dei disegnini grigi come sui vestiti d’estate delle vecchie bigotte»; e ancora i grilli, con la loro «assurda faccia di cavallo verde», li taglia a pezzi per fare «strani mosaici con le zampe su una pietra liscia». Non è dunque una natura idillica, quella che fa da teatro alle scorribande di Pin: è una macello, un laboratorio di piccoli orrori, un teatrino gotico dove Pin mette in scena la lezione imparata suo malgrado dalla Storia: che esistono, sempre e ovunque, i forti e i deboli, e sempre e ovunque i forti hanno la meglio. Anche se a volte sembra volerne dubitare, questa è l’amara saggezza raggiunta nel corso della sua minuscola vita. Come quando il Dritto gli ordina di seppellire il falchetto morto di uno dei partigiani: «Verrebbe voglia di buttare il falchetto nella grande aria della vallata e vederlo aprire le ali, e alzarsi a volo, fare un giro sulla sua testa e poi partire verso un punto lontano. E lui, come nei racconti delle fate, andargli dietro, camminando per monti e per pianure, fino a un paese incantato in cui tutti siano buoni. Invece Pin depone il falchetto nella fossa e fa franare la terra sopra, con il calcio della zappa».
Troverà il suo Amico, Pin, e lo troverà proprio nel mondo dei grandi: Cugino, con il suo mantello scuro e le mani grandi, che sembrano di pane, le poche parole brusche e il peso di un grande dolore sulle spalle. Un altro tradito dalla vita, che trova nella guerra un senso, un’alternativa, uno scopo per vivere. Lui, alla fine del romanzo, sarà incaricato di uccidere la sorella di Pin che fa la spia per i tedeschi. Ma Pin non lo capirà, Pin non riesce a decifrare la Storia nei suoi significati profondi: per il bambino, essa rimane un geroglifico , un enigma, uno scarabocchio sulla superficie, come quegli strani mosaici fatti di zampe di grillo, come gli schizzi verdi di rana spiaccicata su un sasso. Conta solo aver trovato l’Amico, e solo in ragione di questo umile affetto umano Il Sentiero dei nidi di ragno può chiudersi con un’immagine di speranza.
«E continuarono a camminare, l’omone e il bambino, nella notte, in mezzo alle lucciole, tenendosi per mano.»