Lessico familiare è una delle opere più famose di Natalia Ginzburg. Con
lo stile chiaro, scorrevole, quasi ingenuo che la contraddistingue, ci narra
la storia della sua famiglia, con un'eccellente caratterizzazione dei
personaggi che ruotano di volta in volta attorno alla vita della scrittrice ( familiari,
amici, conoscenti, personaggi della cultura torinese del tempo...).
Si percepisce una certo rapporto con la
"Recherche" di Proust:
quest'opera viene sovente citata nel testo, ed è apprezzata dalla stessa
scrittrice (che solo pochi anni prima della pubblicazione di questo romanzo
stava appunto lavorando alla traduzione in italiano della "Recherche"); lo
stile narrativo, incentrato su vicende familiari che delineano, a poco a
poco, una veduta d'insieme della storia e delle vite narrate, ha qualche
punto di contatto con l'opera dell'autore francese.
Il linguaggio di
Lessico familiare è apparentemente referenziale ma in realtà evocativo, allusivo, in
grado di tratteggiare la realtà sia con quanto afferma esplicitamente che
con quello che sottintende. Si fa riferimento soprattutto al valore del
parlato come retroterra conoscitivo e di esperienze comuni.
Si distingue nell'opera una circolarità della vicenda, che
rimanda al comune lessico usato dai vari personaggi: espressioni,
parole, modi di dire che periodicamente riappaiono nella narrazione,
rievocando periodi storici differenti della famiglia.
Un continuo gioco di richiami
che diviene dapprima, autocitazione,
poi, nuova trama e nuovi intenti narrativi.
La capacità di riportare alla mente situazioni
lontane nella dimensione temporale, giocando sul potere evocativo oltre
che referenziale delle parole è la
caratteristica tematica particolare dell'opera.
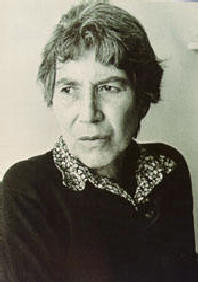
Natalia Ginzburg
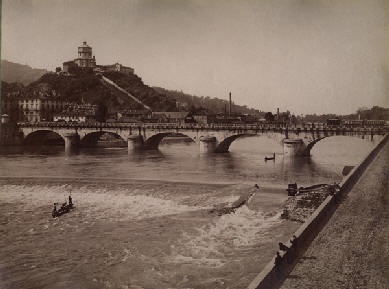
Il Po a Torino
"Noi siamo cinque
fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero: e non
ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo, possiamo essere, l'uno con l'altro,
indifferenti o distratti, ma basta, fra noi, una parola. Basta una parola,
una frase: una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte
nella nostra infanzia. Ci basta dire: "Non siamo venuti a Bergamo
per fare campagna" o "De cosa spussa l'acido solfidrico", per ritrovare ad un tratto
i nostri antichi rapporti, e la nostra infanzia e giovinezza, legata
indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o
parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di
una grotta, fra milioni di persone.
Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati,
sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiri-babilonesi, la
testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che
sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione
del tempo.
Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che
sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e resuscitando nei punti piú
diversi della terra, quando uno di noi dirà - egregio signor Lippman - e
subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre:
"Finitela con questa storia! L'ho sentita già tante di quelle volte!".
La memoria: unica forma di comunicazione?
Il tema della memoria è quello che piú caratterizza la narrativa di Natalia
Ginzburg. E Lessico famigliare coincide con il pieno recupero della memoria:
è basato infatti sull'evocazione del passato, del passato di Natalia ma
soprattutto di quello di tutte le persone (familiari, amici) che agiscono
intorno alla scrittrice.
Esso è però solo "in parte" il libro della sua infanzia e della sua
giovinezza, perché chiunque di noi, pensando ad un avvenimento passato non
lo ricorderà mai in tutte le sue sfaccettature,
ma "solo in parte". Così
Natalia non ricorda tutti i fatti che caratterizzano la sua vita.
Non è solo a questo, però, che la scrittrice si riferiva quando pronunciava
quelle parole. Se infatti la memoria può restituire il passato, essa però ne
trattiene con sé un pezzo, e questo ci impedisce di assaporare quella
felicità di possedere un'altra volta ciò per cui proviamo grande nostalgia.
I ricordi si presentano alla memoria attraverso le parole, parole e frasi
che costituiscono un preciso gergo familiare, attraverso il quale vive il
cuore del passato.
Cosí per la Ginzburg il tempo passa e separa gli uomini i quali, però, sono
indissolubilmente uniti dai ricordi. Forse è questa una possibile soluzione
al dramma della solitudine? Forse è la memoria la sola forma di
comunicazione a noi concessa? In effetti i libri della Ginzburg sono tutti
pervasi di memorie lontane e vicine e della scrittura memoriale la Ginzburg
si servì sempre per instaurare un rapporto tra lei e il mondo che le girava
intorno.
Ritroviamo tutto questo nella sua vita: sin da piccola, sola e diversa dagli
altri, Natalia inizia a scrivere per superare questa sua condizione di
estraneità nei confronti sia del vicino ambiente familiare sia del mondo
civile e sociale del suo tempo. Ella dunque trova nella scrittura non il
modo per chiudersi in se stessa, ma un mezzo con cui scavare dentro di sé e
dentro i suoi amici e parenti, per capirsi e per capirli e, in definitiva,
per aprirsi al dialogo.
da
http://www.clio.it/sr/ce/palmieri/annuario/nginzburg.html
Nasce il 14 luglio del 1916 a
Palermo, da Giuseppe Levi e Lidia Tanzi. In quegli anni, il padre,
triestino, insegnava anatomia comparata all’Università di Palermo; più
tardi, divenne un biologo e un istologo di grande fama. La madre, lombarda,
era figlia di Carlo Tanzi, avvocato socialista, amico di Turati. Figure di
primo piano, nella famiglia, Eugenio Tanzi, psichiatra, zio della madre, il
musicologo Silvio Tanzi, morto giovane, fratello della madre, e Cesare Levi,
fratello del padre, critico teatrale e studioso.
Nel 1919 la Famiglia Levi si trasferisce a Torino. Natalia non frequenta le
elementari; studia in casa.
Nel 1927 è iscritta al Liceo-Ginnasio Vittorio Alfieri. Nel 1935 consegue la
maturità classica e si iscrive alla Facoltà di Lettere. Frequenta i corsi di
Augusto Rostagni e Ferdinando Neri. Non si è mai laureata.
Scrive e pubblica i primi racconti su "Solaria", "Il Lavoro", "Letteratura"
(1934-1937).
Nel 1938 sposa Leone Ginzburg. Nel 1940 segue il marito al confino in
Abruzzo, a Pizzoli, un villaggio a quindici chilometri dall’Aquila, coi
figli Carlo e Andrea. All’Aquila nasce la figlia Alessandra.
Nel 1942 pubblica, presso la casa editrice Einaudi, il suo primo romanzo,
"La strada che va in città", con lo pseudonimo di Alessandra Tornimparte.
Nel 1943, il 26 luglio Leone Ginzburg lascia il confino, rientra a Torino e
di lí passa a Roma, dove in settembre comincia la lotta clandestina. Il
primo novembre, coi tre figli, Natalia raggiunge il marito a Roma, in un
alloggio di fortuna in via XXI Aprile. Il 20 novembre Leone è arrestato
dalla polizia italiana nella tipografia clandestina di via Basento. E’
trasferito nel braccio tedesco di Regina Coeli.
Il 5 febbraio del ’44 muore Leone Ginzburg nelle carceri di Regina Coeli.
Dal giorno dell’arresto fino a quello della morte, Natalia non vide mai il
marito.
Dopo una provvisoria sistemazione nel convento delle Orsoline al Nomentano,
si trasferisce con i figli a Firenze, in casa della zia materna. Liberata
Firenze, ritorna a Roma in ottobre. Prende alloggio in una pensione valdese
a S. Maria Maggiore, poi in casa di un’amica, nel quartiere Prati. E’
assunta come redattrice dalla casa editrice Einaudi.
Nel 1945 ritorna a Torino, nella vecchia casa dei genitori in via
Pallamaglio (oggi via Morgari). Continua a lavorare nella casa editrice
Einaudi.
Nel 1947 pubblica il romanzo "E’
stato così".
Nel 1950 sposa Gabriele Baldini, professore incaricato di Letteratura
inglese a Trieste; Natalia continua a vivere a Torino.
Si trasferisce a Roma con il marito, nel 1952. Qui pubblica il romanzo "Tutti
i nostri ieri".
E’ a Londra, nel 1960, con il marito Baldini, chiamato a dirigere l’Istituto
Italiano di cultura.
Nel 1961 pubblica "Le piccole virtù". Nel 1962 è la volta del romanzo breve
"Le voci della sera". Ritorna con il marito a Roma e prende alloggio in
piazza Campo Marzio.
Nel 1963 pubblica il romanzo autobiografico "Lessico
famigliare".
Nel 1965 scrive la commedia "Ti
ho sposato per allegria"
per l’attrice Adriana Asti, che viene rappresentata con successo. Seguono
nel 1968 le commedie "L’inserzione" e "La segretaria".
Nel 1969 muore a Roma il marito Gabriele Baldini.
Nel 1970 la Ginzburg pubblica la raccolta di saggi "Mai
devi domandarmi".
Nel 1973 pubblica la raccolta di commedie "Paese di mare" e il romanzo, metà
narrativo e metà epistolare, "Caro
Michele" dal quale è
stato tratto il film omonimo del regista Mario Monicelli (1976).
Nel 1974 pubblica la raccolta di saggi e di articoli "vita
immaginaria".
Nel 1977 scrive, col titolo "Famiglia", due racconti lunghi, "Famiglia"
e "Borghesia".
Nel 1983 pubblica la ricerca storico-epistolare "La Famiglia Manzoni". E’
eletta deputata alla Camera nel gruppo degli Indipendenti di sinistra.
Nel 1984 pubblica il romanzo epistolare "La
città e la casa" e nel
1990 il saggio "Serena
Cruz o la vera giustizia".
Nel 1991 muore nella sua casa di Roma durante la notte tra il 6 e il 7
ottobre.
La casa editrice Einaudi pubblica, nel 1999, il romanzo postumo "E’
difficile parlare di sé": testo integrale di una serie di conversazioni
radiofoniche in cui la Ginzburg racconta la propria vita e la propria opera
letteraria