A.
Manzoni, I promessi sposi
Cap. XI, Renzo
e le prime impressioni sulla città di Milano.
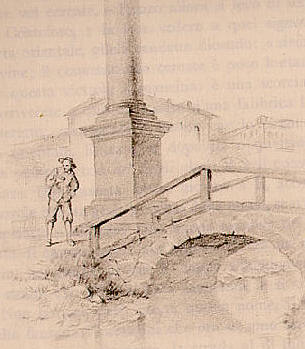
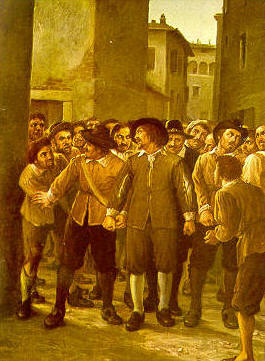
Renzo,
salito per un di que' valichi sul terreno più elevato,
vide quella gran
macchina del duomo sola sul piano, come se, non di mezzo a una città, ma
sorgesse in un deserto;
e si fermò su due piedi,
dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava maraviglia, di cui
aveva tanto sentito parlare fin da bambino.
Ma
dopo qualche momento, voltandosi indietro,
vide all'orizzonte quella
cresta frastagliata di montagne, vide distinto e alto tra quelle il suo Resegone, si sentì tutto rimescolare il sangue, stette lì alquanto a
guardar tristamente da quella parte, poi tristamente si voltò, e seguitò
la sua strada. A poco a poco
cominciò poi a scoprir
campanili e torri e cupole e
tetti; scese allora
nella strada, camminò ancora qualche tempo, e quando s'accorse d'esser
ben vicino alla città,
s'accostò a un viandante,
e, inchinatolo, con tutto quel
garbo
che seppe, gli disse: - di grazia, quel signore. - Che volete, bravo
giovine?
- Saprebbe insegnarmi la
strada più corta, per andare al convento de' cappuccini dove sta il padre
Bonaventura?
L'uomo a cui Renzo s'indirizzava, era un
agiato abitante del contorno,
che, andato quella mattina a Milano, per certi suoi affari, se ne tornava,
senza aver fatto nulla, in gran fretta, ché
non vedeva l'ora di trovarsi a
casa, e avrebbe fatto volentieri di meno di quella fermata.
Con tutto ciò, senza dar segno
d'impazienza, rispose molto gentilmente:
- figliuol caro, de' conventi ce n'è più d'uno: bisognerebbe che mi
sapeste dir più chiaro quale è quello che voi cercate -. Renzo allora si
levò di seno la lettera del padre Cristoforo, e la fece vedere a quel
signore, il quale, lettovi: porta orientale, gliela rendette dicendo: -
siete fortunato, bravo giovine; il convento che cercate è poco lontano di
qui. Prendete per questa viottola a mancina: è una scorciatoia: in pochi
minuti arriverete a una cantonata d'una fabbrica lunga e bassa: è il
lazzeretto; costeggiate il fossato che lo circonda, e riuscirete a porta
orientale. Entrate, e, dopo tre o quattrocento passi, vedrete una
piazzetta con de' begli olmi: là è il convento: non potete sbagliare. Dio
v'assista, bravo giovine -. E, accompagnando l'ultime parole con un gesto
grazioso della mano, se n'andò.
Renzo rimase stupefatto e
edificato della buona maniera de' cittadini verso la gente di campagna; e
non sapeva ch'era un giorno fuor dell'ordinario, un giorno in cui le cappe
s'inchinavano ai farsetti.
Fece la strada che gli era stata insegnata, e si trovò a porta
orientale......
La seconda parte del capitolo XI è interamente dedicata a Renzo , che sta
per entrare in Milano.
L’ingresso in città
lo proietta in un mondo nuovo e sconosciuto
e produce nel giovane alcune riflessioni: infatti nulla
corrisponde alle sue aspettative.
Egli è colpito nel vedere la mole
del duomo
che si rileva sul resto delle costruzioni; è stupito e meravigliato dalla
stranezza inusuale del paesaggio.
Poi rivolge lo sguardo indietro al Resegone, il monte che sta dietro la
zona di Lecco, che ha abbandonato da poco. Ciò lo
turba profondamente (
si sentì tutto
rimescolare il sangue ).
Si anticipa anche qualcosa dell'avventurosa
permanenza di Renzo in città
attraverso alcuni
indizi,
che il narratore inserisce in queste fasi della vicenda.
La
strana cortesia
dell'agiato abitante,
che si rivolge a
Renzo con inusuale affabilità,
stupisce il nostro protagonista. Manzoni ricorda che
in quel giorno in
effetti era accaduto qualcosa di particolare in città
( l'assalto ai forni ), che aveva intimorito non poco la popolazione
benestante e l'aveva indotta a comportamenti molto cauti nei confronti dei
popolani.
Renzo entra in città e durante la sua permanenza a Milano, avrà la possibilità di vivere un’esperienza preziosa, che lo aiuterà a maturare, non abbandonandosi troppo fiduciosamente alla sincerità, privo di ogni cautela. Appena giunto nei pressi della città, vede della farina e dei pani sparsi sulla strada. Tutto ciò lo rende perplesso, in quanto stenta a individuare la causa dell'accaduto. Come contadino dà al cibo ed in particolare al pane un valore importante: è per lui incomprensibile trovarne traccia per strada. Il particolare aiuta Manzoni ad anticipare i fatti relativi all'assalto al forno delle grucce, di cui sarà testimone lo stesso Renzo e a proporre implicitamente il giudizio negativo sulla furia cieca e distruttiva dei moti popolari milanesi.
Il tema del
contadino inurbato che
vive un'esperienza inusuale e rischiosa,
acquista un rilievo particolare soprattutto attraverso la particolare
focalizzazione operata da Manzoni.
Renzo, vittima dei soprusi di Don Rodrigo, sradicato dal paese, costretto, suo
malgrado, a viaggiare,
diviene, fin dall'inizio della sua permanenza
in città, cercatore di
giustizia. La città è però minacciosa e le sue misteriose leggi < calcolo,
spregiudicatezza degli uomini, astuzia, violenza gratuita....> sfuggono
del tutto a Renzo. Egli non saprà trovare qui il terreno adatto per dar
corpo alle sue rivendicazioni contro l'ingiustizia,
anzi sarà paradossalmente lui stesso a doversi
difendere dalla giustizia.
Cap.
XIV, La folla si dirada dopo la liberazione del vicario di Provvisione
La
folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a
sinistra, per questa e per quella strada. Chi andava a casa, a accudire
anche alle sue faccende; chi s'allontanava, per respirare un po' al largo,
dopo tante ore di stretta; chi, in cerca d'amici, per ciarlare de' gran
fatti della giornata. Lo stesso sgombero s'andava facendo dall'altro
sbocco della strada, nella quale la gente restò abbastanza rada perché
quel drappello di spagnoli potesse, senza trovar resistenza, avanzarsi, e
postarsi alla
casa del vicario.
Accosto a quella stava ancor condensato il
fondaccio, per dir così, del tumulto;
un branco di birboni, che
malcontenti d'una fine così fredda e così imperfetta d'un così grand'apparato, parte brontolavano, parte bestemmiavano, parte tenevan
consiglio, per veder se qualche cosa si potesse ancora intraprendere; e,
come per provare, andavano urtacchiando e pigiando quella povera porta,
ch'era stata di nuovo appuntellata alla meglio.
All'arrivar del drappello,
tutti coloro, chi diritto diritto, chi baloccandosi, e come a stento, se
n'andarono dalla parte opposta, lasciando il campo libero a' soldati, che
lo presero, e vi si postarono, a guardia della casa e della strada. Ma
tutte le strade del contorno erano seminate di crocchi: dove c'eran due o
tre persone ferme, se ne fermavano tre, quattro, venti altre: qui
qualcheduno si staccava; là tutto un crocchio si moveva insieme: era come
quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa, e gira per l'azzurro del
cielo, dopo una burrasca; e fa dire a chi guarda in su: questo tempo non
è rimesso bene. Pensate poi che
babilonia di discorsi. Chi raccontava con
enfasi i casi particolari che aveva visti; chi raccontava ciò che lui
stesso aveva fatto; chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene, e
lodava Ferrer, e pronosticava guai seri per il vicario; chi,
sghignazzando, diceva: - non abbiate paura, che non l'ammazzeranno: il
lupo non mangia la carne del lupo -; chi più stizzosamente mormorava che
non s'eran fatte le cose a dovere, ch'era un inganno, e ch'era stata una
pazzia il far tanto chiasso, per lasciarsi poi canzonare in quella
maniera.
E' questa una delle tante scene di massa, in cui il popolino milanese
viene descritto in occasione dei disordini scoppiati attorno ai forni,
dopo il rincaro del prezzo del pane. La folla viene vista come un elemento
eterogeneo, privo di una precisa strategia d'azione (
La folla rimasta
indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra, per
questa e per quella strada )
nel momento in cui si
dirada in piccoli gruppi disordinati, che ora si separano ora si
riaggregano al comparire di qualche nuova notizia. In particolare
si è appena concluso
l'assalto alla abitazione del vicario di provvisione,
difeso dalla milizie spagnole e salvato dalla furia popolare anche con il
contributo di Renzo. La scarsa simpatia per i moti popolari da parte di
Manzoni viene riconfermata dalla descrizione dei
comportamenti provocatori
di qualche estremo sobillatore,
che cerca invano di protrarre ancora per un po' i disordini,
rammaricandosi che il tutto si stia pacificamente concludendo.
Cap XXXII , La furia della peste si impadronisce della città.
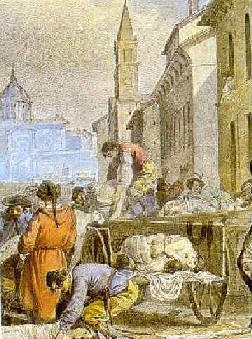

Da
quel giorno,
la furia del contagio andò sempre crescendo: in poco tempo,
non ci fu quasi più casa che non fosse toccata: in poco tempo la
popolazione del lazzeretto,
al dir del
Somaglia citato di sopra, montò da
duemila a dodici mila: più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a
sedici mila. Il 4 di luglio, come trovo in un'altra lettera de'
conservatori della sanità al governatore, la mortalità giornaliera
oltrepassava i cinquecento. Più innanzi, e nel colmo, arrivò, secondo il
calcolo più comune, a mille dugento, mille cinquecento; e a più di
tremila cinquecento, se vogliam credere al
Tadino.
Il quale anche afferma
che, " per le diligenze fatte o, dopo la peste, si trovò la popolazion di Milano
ridotta a poco più di sessantaquattro mila anime, e
che prima passava le dugento cinquanta mila.
Secondo il
Ripamonti, era di
sole dugento mila: de' morti, dice che ne risultava cento
quaranta mila
da' registri civici, oltre quelli di cui non si poté tener conto. Altri dicon più o meno, ma ancor più a caso.
Si
pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni, addosso ai quali
era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a
ciò che c'era di riparabile in un tal disastro.
Bisognava ogni giorno
sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie:
monatti,
apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più
penosi e pericolosi della pestilenza: levar dalle case, dalle strade, dal lazzeretto, i cadaveri; condurli sui carri alle fosse, e sotterrarli;
portare o guidare al lazzeretto gl'infermi, e governarli; bruciare,
purgare la roba infetta e sospetta.
Nel capitolo XXXI l'autore ci informa di come la
peste probabilmente è
entrata nel Milanese e si è propagata. Egli riferisce i fatti con il
maggior scrupolo storico possibile , sfruttando sia i resoconti degli
storici del '600 ( Ripamonti ) e soprattutto gli atti pubblici del
Tribunale della Sanità
e le relazioni ufficiali, che possono fare chiarezza su
come fosse accolta l'idea del contagio .
Nonostante i richiami del protofisico Settala, che aveva già assistito alla precedente peste del 1576, dove aveva perso la vita Carlo Borromeo, nessuna precauzione viene presa, neppure quella di proibire l'acquisto e lo scambio di oggetti tra la popolazione locale ed i lanzichenecchi , portatori del male.
Il contagio intanto si diffonde e le relazioni del Tribunale sono inascoltate. Anzi una pubblica festa per la nascita del principe Carlo, figlio del re di Spagna, Filippo IV , facilita il diffondersi del contagio, visto l'affollamento crescente di popolazione in Milano. Lo stesso esito avrà purtroppo una processione voluta dalla popolazione per scongiurare la diffusione ulteriore del male. Federico Borromeo si lascia convincere a far apparire in pubblico i sacri resti del corpo di San Carlo; la comune devozione ( di carattere superstizioso, lascia capire Manzoni ) raggiunge gli effetti opposti: un aumento della mortalità legata alla promiscuità dei corpi ed alla facilità dei contatti.
Anche se
inizialmente la reazione delle autorità è quella di non dar credito al
male , il progredire delle morti, convince della sua esistenza. Ma ben
presto un'altra falsa congettura si sostituisce ad
una valutazione più oggettiva e realistica della situazione. Sono gli
untori, gente malvagia ed infida, quasi presenze diaboliche, assoldate
forse da nemici della Spagna a diffondere volutamente il contagio
con polveri venefiche, unguenti sparsi sulle
superfici delle chiese o delle case o attraverso ogni altra forma di
contatto furtivamente provocato.
Manzoni mette in relazione il sospetto degli untori a due caratteri della
cultura del tempo: l'ignoranza e la superstizione popolare e l'enorme
impreparazione medica e sanitaria.
La mentalità superstiziosa del popolo,
assecondata purtroppo dalle autorità, trova
più facile attribuire a generiche forze del male le
cause del contagio, che non sa come fronteggiare.
Del resto
l'enorme ignoranza medica finirà col tramutarsi in follia collettiva
nel processo agli untori.
Le notizie offerte
da Manzoni circa gli sviluppi della peste a Milano
sono rigidamente storiche
- come vengono annotate da scrittori e cronisti del tempo - ed evidenziano
soprattutto i pareri inascoltati degli esperti.
Milano è stata preda del contagio per la seconda volta in meno di cento
anni e le conseguenze a livello di decremento
demografico e di mancata efficienza nei servizi sanitari
( lazzaretto, monatti, apparitori...) sono
ampiamente documentate. La situazione della
città, attanagliata dalla peste, è poi
pesantemente
condizionata dell'inefficienza del governo spagnolo
e dalla vittoria di teorie irrazionali ed assolutamente non
scientifiche ( come quelle degli untori ),
che impediscono di approntare adatti rimedi
ad un'epidemia, in parte almeno prevedibile e maggiormente controllabile.