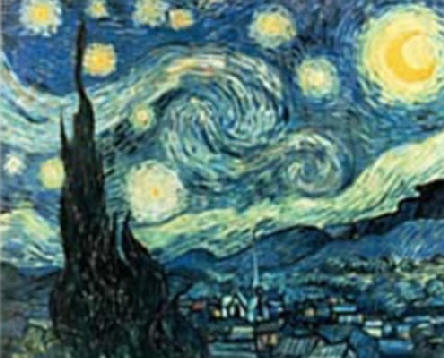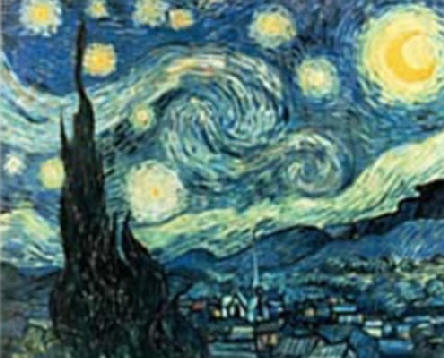|
X Agosto è
forse la poesia più famosa in cui Pascoli
rievoca il più traumatico dei suoi drammi
giovanili, l’uccisione del padre, avvenuta il 10 agosto del 1867,
il giorno di san Lorenzo.
Il poeta simbolicamente vede
nella pioggia di
stelle che ricade sulla Terra in quella notte, il pianto del cielo sulla
cieca ed oscura malvagità degli uomini e colloca il suo
dolore personale e privato in una dimensione universale.
Nell’incipit egli dice esplicitamente ‘..... io lo so perché /
tanto
di stelle per l’aria tranquilla / arde e cade .... ad anticipare
il riferimento metaforico fondamentale del breve testo. Tuttavia, invece che
approfondire concettualmente il senso di questa lirica intuizione, egli
soggiace al peso del dramma personale,
rivissuto fino in fondo e rappresentato in forma incisiva
attraverso un nuovo simbolico
parallelismo.
Una rondine tornava al suo nido portando
cibo ai suoi piccoli; anch'essa come l'uomo, proditoriamente ucciso, non
farà ritorno. L’analogia si
esprime soprattutto nella
corrispondenza tra il nido della
rondine e il nucleo familiare
del poeta, entrambi deprivati
dell'elemento cardine della piccola comunità.
Un altro testo pascoliano ritorna
sull'argomento della morte paterna: si tratta della poesia intitolata
emblematicamente
Un ricordo
contenuta nella raccolta Canti di Castelvecchio. Questa composizione,
ancor più di X Agosto, sosta sui particolari, narrativamente
riproposti con assoluta minuzia, della partenza del padre, degli oscuri
timori della figlia Margherita, dello struggente pianto della piccola
Maria, che non vorrebbe staccarsi da lui. Anche in questi versi si
nascondono alcune tracce
ambiguamente simboliche, che
evidenziano una strana percezione
di inquietudine nella natura,
testimone di vitalità piena che percepiamo dissonante a fronte del dramma
familiare che si sta preparando. Innanzitutto
la muta presenza degli animali che fanno
da contrappunto alla vicenda umana:
le rondini che andavano e
tornavano / ai nidi, piene di felicità, le tortori che tubarono... in
cova... nella paglia, la cavalla storna che ..volgea
la testa smunta alla bimba. Quindi la piccola Maria, bimba
implorante nel tragico giorno dell'uccisione, ora unica testimone dell'unità
familiare distrutta e unica fedele compagna del poeta.
I parallelismi tra le due poesie -
accanto ai richiami evidenti ed
ossessivi al tema della morte, che
si rintracciano, sotto forma di simbolismi di vario genere, in un po' tutta
la produzione dell'autore - testimoniano di una
connotazione permanente
della poesia pascoliana. Essa si nutre costantemente di memoria e questa
tende a a fissarsi ossessivamente, a farsi, da traumatico vincolo
esistenziale, motivo di creatività poetica continuamente variato.
|
|
X Agosto- da Myricae
San Lorenzo, io lo so
perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Ritornava una rondine al
tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de’ suoi rondinini.
Ora è là come in croce,
che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che
attende,
che pigola sempre più piano.
Anche un uomo tornava al
suo nido:
l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido
portava due bambole in dono...
Ora là, nella casa
romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano
E tu, Cielo, dall’alto
dei mondi
sereni, infinito, immortale,
Oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!
|
|
Un ricordo - dai Canti di
Castelvecchio Andavano e tornavano
le
rondini,
intorno alle grondaie della Torre,
ai rondinotti
nuovi. Era d'agosto.
Avanti la rimessa era già pronto
il calessino. La
cavalla storna
calava giù, seccata dalle mosche,
l'un dopo l'altro tutti quattro i tonfi
dell'unghie su le selci della corte.
Era un dolce mattino, era un bel giorno:
di San Lorenzo. Il babbo disse: «Io vo».
E in un gruppo tubarono
le tortori.
Esse là nella paglia erano in cova.
Tra quel hu hu, mia madre disse: «Torna
prestino». «Sai che volerò!» «Non correr
tanto: la tua
stornella è appena doma».
«Eh! mi vuol bene!» «Addio». «Addio». «Vai solo?
non prendi Jên?» «Aspetto quel signore
da Roma...» «E` vero. Ti verremo incontro
a San Mauro. Io sarò sotto la Croce.
Tu ci vedrai passando». «Io vi vedrò».
E Margherita, la sorella grande,
di sedici anni, disse adagio: «Babbo...»
«Che hai?» «Ho, che leggemmo nel giornale
che c'è gente che uccide per le strade...»
Chinò mio padre tentennando il capo
con un sorriso verso lei. Mia madre
la guardò coi suoi cari occhi di mamma,
come dicendo: A cosa puoi pensare!
E le rondini
andavano e tornavano,
ai nidi, piene di felicità.
Mio padre palpeggiò
la sua cavalla
che l'ammusò con cenno familiare.
Riguardò le tirelle e il sottopancia,
e raccolte le briglie, calmo e grave,
si volse ancora a dire: «Addio!» Mia madre
s'appressò con le due bimbe per mano:
la più piccina a lui toccò la mazza.
Egli teneva il piede sul montante.
E in un gruppo le tortori tubarono,
e si sentì: «Papà! Papà! Papà!»
E un poco presa egli sentì, ma poco
poco, la canna come in un vignuolo,
come v'avesse cominciato il nodo
un vilucchino od una passiflora.
Sì: era presa in una mano molle,
manina ancora nuova, così nuova
che tutto ancora non chiudeva a modo.
Era la bimba che vi avea ravvolte,
come poteva, le sue dita rosa,
e che gemeva: «No! no! no! no! no!»
Mio padre prese la sua bimba in collo,
col suo gran pianto ch'era di già roco;
e la baciò, la ribaciò negli occhi
zuppi di già per non so che martoro.
«Non vuoi che vada?» «No!» «Perché non vuoi?»
«No! no!» «Ti porto tante belle cose!»
«No! no!» La pose in terra: essa di nuovo
stese alla canna le sue dita rosa,
gli mise l'altro braccio ad un ginocchio:
«No! no! papà! no! no! papà! no! no!»
Non s'udì che quel pianto e quei singulti
nel tranquillo mattino tutto luce.
Più non raspava i ciottoli con l'unghia
la
cavalla, e volgea la testa smunta
alla bimba. E
le tortori, hu, hu!
Povera bimba! non avea compiuti
due anni, e ancor dormiva nella culla.
Sapea di latte il suo gran pianto lungo:
assomigliava ad un vagir notturno.
Mio padre disse: «Non partirò più».
Jên, a un suo cenno, menò fuor del muro
la cavalla,
aspettando ad un altro uscio.
Lontanò essa con un ringhio acuto.
E mio padre baciò la creatura,
e le disse: «Non vado: entro; mi muto,
e sto con te. Perché tu sia sicura,
prendi la canna». Rabbrividì tutta
essa, come un uccello quando arruffa
le piume; le spianò; poi con le due
braccia abbracciò la canna di bambù.
Ed aspettò. Aspetta ancora. Il babbo
non tornò più. Non si rivide a casa.
Lo portarono a sera in camposanto,
lo stesero in un tavolo di marmo,
dissero, oh! sì! dissero ch'era sano,
e che avrebbe vissuto anche molti anni.
Ma uno squarcio aveva egli nel capo,
ma piena del suo sangue era una mano.
Maria! Maria! quel pegno di tuo padre,
ciò che di lui rimase, ove sarà?
Sorella, a volte penso che tu l'abbia,
che tu lo tenga ancora fra le braccia.
Così mi pare a volte, che ti guardo
e tu non vedi, ché tu stai pregando.
Tieni le braccia in croce, un poco lasse;
e tieni ancora gli occhi fissi in alto.
Stai come quando ti lasciò tuo padre;
sicura, come allora. Ma una lagrima
ancora scorre a te, di quelle, e il labbro
balbetta ancora, sì: «Papà! Papà!»
|