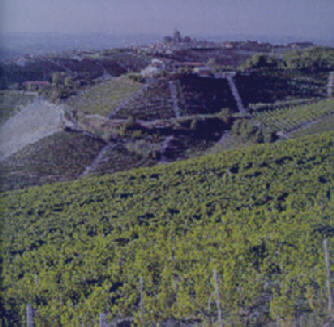
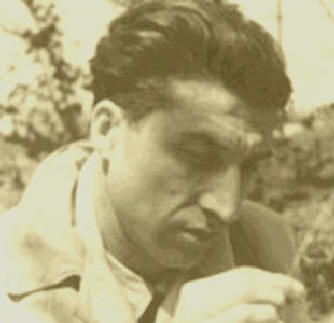
Sotto la luna estiva delle Langhe ecco sprigionarsi il falò del casotto
della Gaminella, bruciata in un impeto di violenza dal Valino, rogo
distruttivo di tutte le memorie della terra contadina di Pavese. La luna non
illumina più i falò propiziatori dei contadini, che attendono fertilità
dalla terra, ma apre la sua luce sulle terre della fatica e della follia
omicida, attraversate anche dal tempo della guerra partigiana, che ha
causato altre morti per vendetta.
Anguilla, l'emigrante, tornato a rivedere la sua Langa, la trova così
profondamente mutata nei contorni di vita, anche se la fiducia nelle forze
rigeneratrici della natura - di cui la luce lunare sembra essere depositaria
- continuano al alimentare le speranze di rigenerazione di questo mondo.
Il falò della Gaminella
Qualcuno correva sullo
stradone nella polvere, sembrava un cane. Vidi ch'era un ragazzo: zoppicava
e ci correva incontro. Mentre capivo ch'era Cinto, fu tra noi, mi si buttò
tra le gambe e mugolava come un cane.
- Cosa c'è?
Lì per li non gli credemmo. Diceva che suo padre aveva bruciato la casa. -
Proprio lui, figurarsi,
- disse Nuto.
- Ha bruciato la casa, - ripeteva Cinto. - Voleva ammazzarmi... Si è
impiccato... ha bruciato la casa...
- Avranno rovesciato la lampada, - dissi.
- No, no, - gridò Cinto, - ha ammazzato Rosina e la nonna. Voleva
ammazzarmi ma non l'ho lasciato... Poi ha dato fuoco alla paglia e mi
cercava ancora, ma io avevo il coltello e allora si è impiccato nella
vigna...
Cinto ansava, mugolava, era tutto nero e graffiato. S'era seduto nella
polvere sui miei piedi, mi stringeva una gamba e ripeteva: - Il papà si è
impiccato nella vigna, ha bruciato la casa... anche il manzo. I conigli sono
scappati, ma io avevo il coltello... E' bruciato tutto, anche il Piola ha
visto...
Nuto lo prese per le spalle e
lo alzò su come un capretto.
- Ha ammazzato Rosina e la nonna?
Cinto tremava e non poteva parlare.
- Le ha ammazzate? - e lo scrollò.
- Lascialo stare, - dissi a Nuto, - è mezzo morto. Perché non andiamo a
vedere?
Allora Cinto si buttò sulle mie gambe e non voleva saperne.
- Sta' su, - gli dissi, - chi venivi a cercare?
Veniva da me, non voleva tornare nella vigna. Era corso a chiamare il
Morone e quelli del Piola, li aveva svegliati tutti, altri correvano già
dalla collina, aveva gridato che spegnessero il fuoco, ma nella vigna non
voleva tornare, aveva perduto il coltello.
- Noi non andiamo nella vigna, - gli dissi. - Ci fermiamo sulla strada, e
Nuto va su lui. Perché hai paura? Se è vero che sono corsi dalle cascine,
a quest'ora è tutto spento...
C'incamminammo tenendolo per mano. La collina di Gaminella non si vede
dalla lea, è nascosta da uno sperone. Ma appena si lascia la strada maestra
e si scantona sul versante che strapiomba nel Belbo, un incendio si dovrebbe
vederlo tra le piante.
Non vedemmo nulla, se non la nebbia della luna.
Nuto, senza parlare,
diede uno strattone al braccio di Cinto, che incespicò. Andammo avanti,
quasi correndo. Sotto le canne si capi che qualcosa era successo. Di lassù
si sentiva vociare e dar dei colpi come abbattessero un albero, e nel fresco
della notte una nuvola di fumo puzzolente scendeva sulla strada.
Cinto non fece resistenza, venne su affrettando il passo col nostro,
stringendomi più forte le dita. Gente andava e veniva e si parlava, lassù
al fico. Già dal
sentiero, nella luce della luna, vidi il vuoto dov'era stato il fienile e la
stalla, e i muri bucati del casotto.
Riflessi rossi morivano a piede del muro, sprigionando una fumata nera.
C'era un puzzo di lana, carne e letame bruciato che prendeva alla gola.
Mi scappò un coniglio tra i piedi.
Nuto, fermo al livello dell'aia, storse la faccia e si portò i pugni sulle
tempie. - Quest'odorel, - borbottò, - quest'odore.
L'incendio era ormai finito, tutti i vicini erano corsi a dar mano; c'era
stato un momento, dicevano, che la fiamma rischiarava anche la riva e se ne
vedevano i riflessi nell'acqua di Belbo. Niente s'era salvato, nemmeno il
letame là dietro.....
Cesare Pavese
Narratore
e poeta italiano (Santo Stefano Belbo, Cuneo, 1908-Torino 1950). Nato da
una famiglia di origine contadina, presto orfano del padre, compì gli
studi a Torino, in un
periodo di transizione tra positivismo e idealismo, lotte operaie e
fascismo. Pavese imparò la grande lezione dei classici e dei realisti
dell'Ottocento e dei contemporanei, strinse
amicizia con molti intellettuali torinesi e,
dopo essersi laureato nel 1930 con una tesi su W. Whitman, insegnò inglese
in scuole serali e private, collaborando intanto a La Cultura con saggi su
Lewis, Twain, Lee Masters, Henry, Melville (del quale nel 1932 tradusse
magistralmente Moby Dick). Nel 1935, dopo
alcuni mesi di carcere scontati per aver servito da
tramite fra alcuni militanti antifascisti, fu
condannato a tre anni di confino a Brancaleone
Calabro, ma dopo un anno poté tornare a Torino
per un condono.
Durante il confino, preparò la stesura di alcuni dei suoi
romanzi brevi:
Il carcere, che
uscì nel 1949 nella raccolta Prima che il
gallo canti, nacque proprio dall'esperienza
di quel periodo. L'esordio di Pavese avvenne nel 1936 con le poesie di
Lavorare stanca:
un genere nuovo, di tipo narrativo, col quale passava dal crepuscolarismo
gozzaniano di certe sue prime esperienze, al
superamento della metrica tradizionale, convinto dalla lezione degli
Americani che il verso possa divenire "strumento" del narrare.
Dopo il confino intensificò la sua attività presso la casa editrice Einaudi;
nel 1941 pubblicò Paesi tuoi,
scritto due anni prima, anche questo accolto, come le poesie, distrattamente
dalla critica. Continuava intanto a tradurre
scrittori americani contemporanei e classici inglesi;
l'armistizio lo sorprese a Roma, ma Pavese riuscì a tornare a Torino e si
rifugiò presso la sorella, in campagna. Finita la guerra, si iscrisse al
Partito comunista; scrisse saggi, articoli di politica, nuove opere di
narrativa, sempre cercando una spinta per
uscire dal suo isolamento e da una disposizione essenzialmente lirica:
Feria d'agosto
(1946), Il compagno
(1947), La bella estate
(1949, premio Strega); Dialoghi con Leucò
(1947), in cui rielabora alcuni miti classici e certe interpretazioni
moderne dell'umanità "primitiva", già apparsi in Feria d'agosto;
La luna e i falò
(1950), nel quale ricompaiono i motivi
cari all'autore: le Langhe, le indimenticabili
figure di amici, di donne, insieme all'incombente senso di tormentosa
delusione per l'esistenza, che Pavese cercò di nobilitare con l'immagine e
il racconto.
Sono queste le due componenti essenziali della sua poetica, più stati
d'animo, impressioni, momenti lirici che trame e personaggi, tanto sono
trasfigurati in mito.
Nel 1950 raccolse le sue poesie vecchie e nuove nel volume
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
(postumo, 1951); poi, colmata la misura del suo disperato soffrire,
si tolse la vita in una camera d'albergo della sua
città, in piena estate, la stagione che è un
altro dei suoi temi ricorrenti. Il suo diario,
Il mestiere di vivere,
pubblicato postumo nel 1952, racchiude la realtà che Pavese ha interpretato
in una sua chiave unica: il senso della morte,
del dolore, della solitudine concepita come una "gioia feroce" e anche come
un tentativo di liberazione, un miraggio, infine, sterile e inutile per chi
si sente fatto invece per gli altri.
Considerato dalla critica uno dei rappresentanti più significativi
nell'ambito della nuova letteratura, P. ha avuto anche il merito, insieme a
pochi altri, di aver liberato la nostra narrativa e la nostra cultura da una
certa tradizione di provincialismo che l'aveva immobilizzata fino al secondo
dopoguerra.
La luna e i falò
Il ritorno alle origini,
la riscoperta di un passato che pareva dimenticato
sono il fulcro dell’ultimo e più
importante romanzo di Cesare Pavese scritto fra il settembre ed il novembre
del 1949 e pubblicato nell’aprile del 1950, quattro mesi prima che l'autore
si suicidasse. Il protagonista è
Anguilla,
un orfano, un “bastardo” cresciuto nelle Langhe, che
ritorna nei luoghi dell’infanzia
e della giovinezza dopo aver fatto fortuna al di là dell’oceano, in un mondo
che pare lontanissimo: l’America.
Il romanzo viaggia su due piani paralleli. Uno legato al passato, con un percorso della memoria articolato in estesi flash-back attraverso i quali il protagonista rivive gli anni passati come servitore di campagna alla “Mora”. L’altro piano corre invece lungo i binari del presente, tempo nel quale l’Anguilla uomo ritrova l’amico-maestro di un tempo, Nuto, e rivede sé stesso nella figura del giovane Cinto. Le campagne e le Langhe in particolare, sono terre di miseria, nelle quali un orfano viene preso in casa per avere le cinque lire di sovvenzione e due braccia in più da usare nei campi. Le Langhe sono di frequente una vita di stenti che spesso si sfoga nella rabbia e sfocia nella follia. Una follia che nasce dalla miseria, una rabbia per una vita senza sfogo. Il personaggio che incarna tutto questo è Valino, il padre di Cinto, che distrugge tutto il suo mondo in una sola notte.
C'è anche la riflessione politica appena accennata, ma ugualmente profonda di un personaggio fondamentale quale è Nuto. In un paese diviso, dove i morti continuano a riaffiorare dalla terra e ad alimentare l’odio egli è il marxista del villaggio, che conosce le ingiustizie, ma vede le difficoltà e le ragioni di ogni parte, che riflette con lucidità sulla situazione del dopoguerra, ma allo stesso tempo crede nel potere della luna e nelle capacità magiche dei falò accesi nella notte di San Giovanni di risvegliare le campagne.
In un passato dominato dalla guerra civile il futuro, come sottolineato da Franco Fortini, è di Cinto, l’orfano zoppo che abita nella casa dove il protagonista è cresciuto e nel quale il protagonista si rivede. Il futuro è suo nonostante l’essere storpio gli impedirà di uscire dalle Langhe e quindi di conoscere il mondo. Il futuro è suo perché Cinto appartiene alla prima generazione che non dovrà fare i conti con la guerra e soprattutto con il dopoguerra. Il futuro è suo perché non potrà essere che così, altrimenti anche la speranza non avrebbe più senso.
Nella seconda parte emergono ulteriori elementi. Questa sezione del romanzo è dominata dal ricordo dell’adolescenza di Anguilla, e potremmo intitolarlo il romanzo della “Mora”. La scena è occupata per buona parte dalla figlie del padrone, Irene, Silvia e Santina. Tutte e tre spinte dalla voglia di evadere dalla campagna, di essere accettate al di fuori della Mora e tutte e tre morte tragicamente. Mentre il giovane Anguilla le vede come esseri superiori, l’autore le dipinge in tutta la loro fragilità, nelle ambizioni e nelle speranze di giovani ragazze di campagna, spezzate dalla vita e da un mondo di vendette, che fuori della Mora non è scopertamente aggressivo e crudele. Santina sarà uccisa per rappresaglia dai partigiani, dopo essere stata scoperta spia dei fascisti.
Il romanzo di Pavese vive sul
piano narrativo attraverso accelerazioni e frenate. Ampie riflessioni
vengono spesso concluse con un periodo che chiude il capitolo ed imprime una
svolta importante all’intreccio. La narrazione procede, dunque, secca e
tagliente, in maniera quasi impietosa nei confronti delle sorti dei
protagonisti. Come già detto,
il paesaggio domina.
Nell’oscillazione tra
presente e passato è proprio il
paesaggio a rimanere
costante.
Nei falò, nelle fasi
lunari, nelle stagioni che si ripetono si rivela l’immutabilità della terra.
Di una terra particolare, le Langhe. Le Langhe, sono colline di profumi e di
gusti forti, di terra a tratti nera e a tratti bianca. Di colline che non
finiscono. Terra dove
«lavorare stanca». Terra
di grande guerra civile e di grandi scrittori ed intellettuali.
Un mondo che agli occhi del
protagonista sembra stia per finire sotto i colpi di una modernità difficile
da decifrare, ma che appare molto pericolosa già ad una prima e fugace
impressione.
L’incendio di Gaminella è un simbolo di tutto questo. Di un mondo che viene perduto in un istante e che ritroviamo sepolto sotto uno strato di cenere e fatto esso stesso cenere. Materia nera come la terra, ma impalpabile ed esposta al vento che la disperderà. I falò che prima costituivano il sogno estivo con il quale la gente delle Langhe si affratellava diventa così un incendio indomabile che distrugge questa flebile parentela che si stabiliva una volta l’anno, per una sola notte tra i langaroli. È dunque la stessa solidarietà contadina che brucia nel rogo di Gaminella. Proprio quella solidarietà che Anguilla rimpiangeva da tanti anni e che non aveva trovato nelle città della California e nel deserto del Nuovo Messico. Solidarietà che lo porta a voler conoscere e seguire il piccolo Cinto. Zoppo nella realtà come il protagonista era zoppo a causa del suo essere trovatello, anzi “bastardo”. Quella zoppia morale, che lo faceva guardare dagli altri con compassione e diffidenza, lo aveva fatto avvicinare a Nuto, il suo maestro, la guida e l’esempio.
Oltre al paesaggio, ne La
luna e i falò un ruolo fondamentale è ricoperto dalla
memoria.
Nel suo ultimo romanzo Pavese inserisce
elementi autobiografici in
maniera, se possibile, maggiore rispetto alle opere precedenti.
Oltre alla dimensione narrativa, il rapporto col passato diventa condizione
mentale. Una riscoperta
dei luoghi della memoria che investe la psicologia del protagonista e la
muta in maniera profonda.
I simboli e le figure che riemergono nascondono però una componente
negativa. Nel suo ritorno
infatti il protagonista si accorgerà che i
luoghi dell’infanzia sono, «un
paese di morti, saturo soltanto di cose e persone scomparse». Il ricordo ed
il ritorno sfociano dunque in una riflessione amara che condiziona non solo
il presente ma, in quest’ottica, anche il passato.