|
La
modernità del concetto di inettitudine ( come disadattamento
al reale ed impotenza ) compare nelle tematiche leopardiane
legate all'emergere nell'umanità dell'elemento razionale. Si
evidenzia con la ragione " il male intrinseco
all'essere originario e permanente delle cose ... nella sua
costernante evidenza (emerge) l'identità di progresso e
decadenza, di avanzamento e distruzione, di verità ed
impotenza, di coscienza e nullità" ( M.A. Rigoni, La strage
delle illusioni ). In queste riflessioni si anticipa una delle
più importanti acquisizioni della modernità che vive appunto nella
costante polarità irrisolta di conoscenza ed errore, di coscienza
ed impossibile illusione. Tutta la tensione romantica a
cogliere l'infinito al di là del contingente, riconduce
"al più sublime dei sentimenti umani: la noia." |
|
"Poco propriamente si dice che la noia è mal comune .
Comune è l'essere disoccupato, o
sfaccendato, per dir meglio; non annoiato. La noia non è
se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa. Più può
lo spirito in alcuno, più la noia è frequente, penosa e terribile.
la massima parte degli uomini trova bastante occupazione in che che
sia, e bastante diletto in qualunque occupazione insulsa; e quando è
del tutto disoccupata, non prova perciò gran pena. Di qui nasce che
gli uomini di sentimento sono sì poco intesi circa la noia, e
fanno il volgo talvolta maravigliare talvolta ridere, quando parlano
della medesima e se ne dolgono con quella gravità di parole, che si
usa in proposito dei mali maggiori e più inevitabili della vita"
( LXVII Zibaldone, Leopardi
)
" La noia è in qualche modo il più sublime dei
sentimenti umani . (......) Il non poter essere soddisfatto
da alcuna cosa terrena , né, per dir così dalla terra intera,
considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole
meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla
capacità dell'animo proprio; immaginarsi il numero dei
mondi infinito, e l'universo infinito, e sentire che
l'animo ed il desiderio nostro sarebbe ancora più grande
che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d'insufficienza e
di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me
il maggior segno di grandezza e nobiltà, che si veggia nella natura
umana. perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e
pochissimo o nulla agli altri animali ( LXVIII Zibaldone, Leopardi
)
" Veramente per la noia non credo che si debba intendere
altro che il desiderio puro della felicità (...)
Il qual desiderio
non è mai soddisfatto; e il piacere propriamente non si
trova. Sicché la vita umana è intessuta parte di dolore e
parte di noia; dall'una delle quali passioni non ha riposo se
non cadendo nell'altra" ( Dialogo di Torquato Tasso e del suo
genio familiare, 1824, Leopardi
)
|
|
Riflettendo
su questi passi troviamo delineate tutte le dinamiche
cognitive ed affettive che guidano l'uomo moderno a definire l'orizzonte
d'attesa circa la sua esistenza, al di là dei confini della
necessità.
Il pessimismo leopardiano non è da intendersi come
condizione puramente negativa del vivere ( rinuncia, rifiuto della
vita, abbandono esangue, verifica di privazione, disperazione...),
quanto invece come lucida tensione dell'animo alla ricerca
del senso dell'esistere.
Si contrappone in Leopardi
il desiderio ( infinito ) di vita alla
costante sua preclusione, la ricerca del piacere
all'impossibile fuga dal dolore. E questa condizione si alterna
al più sublime dei sentimenti umani: la noia, che non può
definirsi altrimenti se non come inesausta e privilegiata ricerca
dell'essere razionale.
A distinguere la meditazione leopardiana dagli altri esiti
romantici c'è l'insistenza ragionativa, la tenacia nel
perseguire i percorsi della demistificazione, la sostanziale assenza
di tragicità nelle rappresentazioni del dramma umano. Leopardi
preferisce l'ironia amara del non senso della vita (
Operette morali ) alla scelta troppo vile del suicidio
( Dialogo di Plotino e Porfirio ), la dignitosa
accettazione del destino della ginestra alle facili fiducie
dell'Illuminismo e della religiosità cattolica.
L'inettitudine dell'uomo leopardiano ad aprire un vero un
dialogo con la natura si gioca sempre e comunque sull'autocontrollo
della ragione e prefigura - tra l'altro - la poetica montaliana,
che tradurrà in versi, con simbologie pregnanti, gli stessi
interrogativi del poeta recanatese. |
|

Casa Leopardi |
|

Cezanne, Giocatori di carte
|
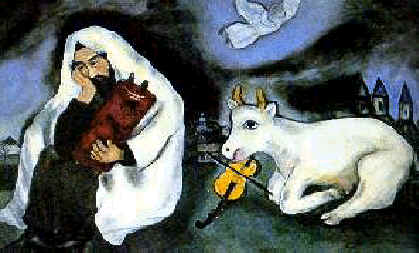
Chagall, Solitudine
|
|
Se
passiamo da Recanati alle affollate strade di Parigi di metà Ottocento
ci imbattiamo in una varietà diversa di inettitudine :
quella di Baudelaire,
l'artista che si misura direttamente con l'ambigua, moderna violenza
della città. la sua è inadeguatezza e disadattamento ai valori
borghesi che essa sottende,
ma anche inconscia attrazione per
le sue fuggevoli parvenze di vita. Dalla violenza del reale ( lo choc
, lo spavento come lo definisce il critico Benjamin ) il poeta
tenta di proteggersi con la sua arte, "dando all'evento un esatto
posto temporale nella sua coscienza". L'arte poetica è definita da
Baudelaire come un duello in cui l'artista, prima di
soccombere, grida di spavento e si riabilita. La parola poetica,
frutto
della riflessione, diviene energica ed aggressiva, provocatoria e
simbolica, capace di trasformare in
eventi psicologici,
ambigui e profondi gli stimoli del reale, da cui l'artista cerca di difendersi.
E' difficile isolare un'argomentazione lineare sul disagio
del poeta che si confronta con la massa anonima ed indifferente del suo
pubblico, con la folla tumultuosa guidata dagli stimoli dell'utile e
del consumo. Ennui
( tedio ) e spleen ( angoscia
disperante ) sono le formule linguistiche di tale condizione, l'albatros
( l'albatro, l'uccello marino che segue le navi che solcano il mare
aperto, volando a sfidare il sole, ma che si adagia anche goffamente
sulla tolda dell'imbarcazione provocando l'ilarità dei marinai.. ) è il simbolo che meglio caratterizza l'immagine del
poeta incapace di farsi accettare nel mondo, svilito e
sbeffeggiato, vilipeso e condannato, vittima della sua stessa grandezza :
|
|
.....Come il principe
dei nembi
è il Poeta; che, avvezzo alla tempesta,
si ride dell'arciere: ma esiliato
sulla terra, fra scherni, camminare
non può per le sue ali di gigante.
Baudelaire, L'albatro
|
|
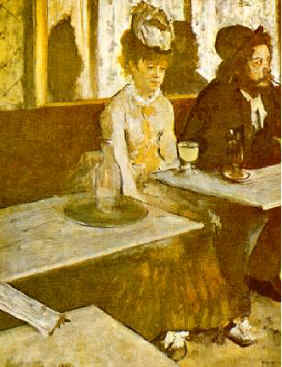
Degas, L'assenzio |
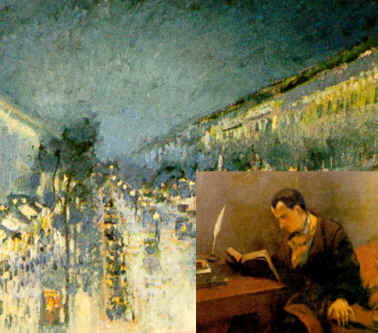 Renoir, Il Pont Neuf -
Courbet, Baudelaire Renoir, Il Pont Neuf -
Courbet, Baudelaire
|
|
Di Baudelaire
vale ancora la pena di analizzare il concetto di spleen,
originalissima forma di melanconia tediosa, di angoscia e di
disgusto esistenziale connotante una sensazione fisica ancor
prima che psicologica. Il male subìto tocca il corpo e
l'animo, è profondo, insidioso e si esprime attraverso immagini di oppressione
e chiusura. L'utilizzo di referenti fisici ( cielo / coperchio,
stanza / umida prigione, soffitti marcescenti, pioggia / sbarre di un
grande carcere, popolo d'infami ragni, campane che sbattono, lunghi
funerali, vessillo nero...) rende quasi espressionistica la
rappresentazione del dolore e dell'impotenza del soggetto: esso rimane
infatti vittima di uno spazio chiuso, circoscritto - della stanza,
della casa, della città, dell'incomunicabilità stessa - dove l'evasione
è impossibile. La vera novità della composizione consiste nella
dolorosa e cruda visionarietà delle connotazioni, che permette al
lettore di rivivere il senso di inerzia angosciosa come un incubo
crudele, ricostruendo lo stato d'animo del poeta attraverso
l'accostamento delle immagini. |
|

Van
Gogh, Campo di grano
con volo di corvi
|

Van Gogh, La camera da
letto |
Spleen
Quando come
un coperchio il cielo pesa
grave e basso ; sull'anima gemente
in preda a
lunghi affanni, e quando versa
su noi, dell'orizzonte tutto il giro
abbracciando, una luce nera e triste
più delle notti; e quando si è mutata
la terra in una
cella umida,; dove
se ne va su pei
muri la Speranza
sbattendo la sua timida ala, come
un pipistrello;
che la testa picchia
su fradici
soffitti; e quando imita
la pioggia, nel mostrare le sue strisce
infinite, le sbarre di una vasta
prigione, e quando un popolo silente
di infami ragni
tende le sue reti
in fondo ai
cervelli nostri, a un tratto
furiosamente scattano campane,
lanciando verso il cielo un urlo atroce
come spiriti erranti, senza patria,
che si mettano a gemere ostinati.
E lunghi funerali lentamente
senza tamburi sfilano né musica
dentro l'anima: vinta, la Speranza
piange, e l'atroce Angoscia sul mio cranio
pianta, despota, il suo vessillo nero.
Da "I fiori del
male" |


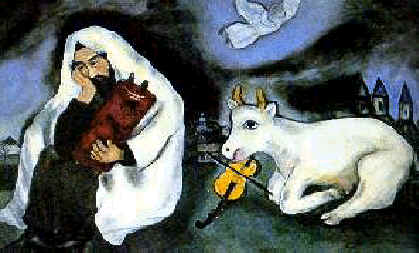
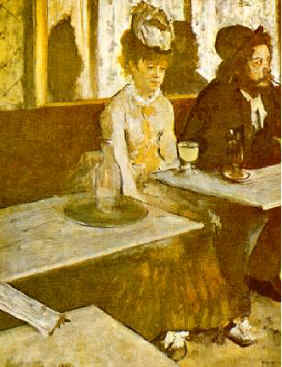
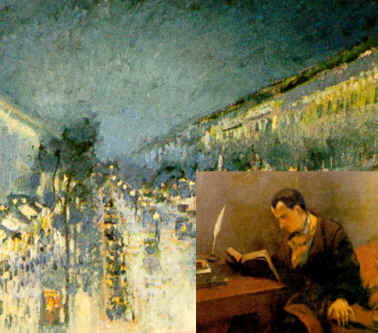 Renoir, Il Pont Neuf -
Courbet, Baudelaire
Renoir, Il Pont Neuf -
Courbet, Baudelaire
