●
L'intimitÓ e il tempo piacevolmente dilatato degli interni
" Sý, tutto potrebbe iniziare cosý, qui, in questo modo, una maniera un po'
pesante e lenta, nel luogo neutro che appartiene a tutti e a nessuno, dove
la gente s'incontra quasi senza vedersi, in cui la vita dell'edificio si
ripercuote, lontana e regolare. Di quello che succede dietro le pesanti
porte degli appartamenti, spesso se non sempre si avvertono solo quegli echi
esplosi, quei brani, quei brandelli, quegli schizzi, quegli abbozzi,
quegli iincidenti o accidenti che si svolgono in quelle che si chiamano le
parti comuni, i piccoli rumori felpati che la passatoia di lana rossa
attutisce, gli embrioni di vita comunitaria che sempre si fermano sul
pianerottolo. Gli abitanti di uno stesso edificio vivono a pochi centimetri
di distanza, separati da un semplice tramezzo, e condividono gli stessi
spazi ripetuti di piano in piano, fanno gli stessi gesti nello stesso tempo,
aprire il rubinetto, accendere la luce, preparare la tavola, qualche
decina di esistenze simultanee che si ripetono da un piano all'altro, da un
edificio all'altro, da una via all'altra
( da G. Perec, La vita istruzioni per l'uso, Hachette - Rizzoli, 1978
- 1997 )
Il passo del narratore e saggista francese
George Perec
fa riflettere sul rapporto che lega la vita esterna e pubblica della
cittÓ ai momenti della vita privata, che si consumano negli
interni delle abitazioni. Questo sottile rapporto esiste senza dubbio
ed a metÓ dell'Ottocento Ŕ ancora legato a referenti culturali
abbastanza condivisi: la sacralitÓ della famiglia, l'educazione dei
figli, il rispetto delle gerarchie parentali, l'uso codificato del tempo
libero, il senso del decoro con l'ossequio rigido alle convenzioni
domestiche.
 col
col
C. Monet, La colazione, 1868

C. Monet, Meditazione, La Signora Monet seduta
sul canapÚ 1870-71
 pi
pi
E. Manet, La signora Manet al piano, 1867 -
1868

C. Manet, La lettura, 1868
 Ch
Ch
A. Renoir, La Signora Charpentier con i figli,
1878

A. Renoir, Giovani ragazze al piano, 1892

G. Boldini, Le sorelle Laskaraky, 1869

A. Roll,
Le Retour du bal, 1886
●
ModalitÓ rappresentative della dimensione privata in Degas
La pittura di Degas
interpreta originalmente la dimensione del privato,
connotandone fortemente certi aspetti. Nel fare questo egli impiega un
linguaggio ancora realistico, adatto a rendere le particolari atmosfere
degli ambienti interni, senza condividere lo stile mimetico degli
impressionisti, che si rifÓ soprattutto alle suggestioni dinamiche della luce naturale.
I suoi modelli sono indubbiamente numerosi, attinti dal
grande museo del passato (
Van Dick, Poussin, Velasquez, Goya, David, Ingres ),
attualizzati, per dare voce ai nuovi eroi della quotidianitÓ. La sua pittura non Ŕ immediata, istintiva, ma esprime
una linea pi¨ meditata,
intellettuale, che fa del disegno e della posa dei
modelli i suoi presupposti ineliminabili. La fotografia, con i
suoi tagli inconsueti e le stampe
giapponesi, allora di moda a Parigi, costituiscono altri referenti
della sua cultura artistica, capaci di suggerire soluzioni
pregnanti a livello espressivo.
In Donna con i crisantemi
( 1865 ), un vaso di fiori si ingigantisce e si dilata
lungo la superficie della tela, finendo per costituire il nucleo
centrale della struttura compositiva. Il volto della donna Ŕ
relegato in posizione secondaria e gli occhi guardano fuori dal quadro,
lateralmente, allargando quasi lo spazio virtuale del dipinto in direzione
orizzontale. Questo strano taglio dell'inquadratura non Ŕ casuale e
sottolinea la marginalitÓ della presenza umana, che l'osservatore non
pu˛ ricondurre ad un preciso contesto di vita. L'oggetto centrale, il vaso di
fiori posto sul piccolo tavolo, diviene da elemento decorativo fulcro
significante - come natura morta - capace di connotare
emblematicamente l'intero ambiente.
Nel ritratto di Hortense Valpincon ( 1871 )
Degas
mostra, nella dolcezza del volto, un vivace ed elegante gusto decorativo.
Egli mette in evidenza
le masse di neri e di bianchi, mutuando questo gusto dal
mondo giapponese. Compaiono sempre
pi¨ numerosi nei ritratti ( di un solo personaggio, di coppie o
di veri e propri gruppi di famiglia )
sfondi decorativi, costituiti da
stoffe, tappezzerie, carte da parati, specchi, che fungono da
"campi
di sospensione" della rappresentazione. Essi hanno la funzione di distanziare l'osservatore nei
confronti di ci˛ che Ŕ troppo facilmente denotativo, naturalistico,
creando una specie di pausa di riflessione, un rallentamento mentale,
che aiuta a meglio gustare le soluzioni formali della composizione,
approdando concettualmente e non emotivamente alla natura dei vari
soggetti.
In
Interno presso Menil-Hubert
la ricchezza di motivi decorativi sulle pareti, gli specchi, i quadri
alle pareti ed il gioco di ombre nella stanza vuota sono orientati
a colmare lo spazio visivo di questo interno, dando un'idea di
chiusura misteriosa e claustrale, che si apre enigmaticamente su un vano
adiacente. Atmosfera un po' angosciante, che vedremo ricomparire in altre
tele di Degas.
Appartiene invece ad un'altra fase della produzione dell'autore
Davanti allo specchio ( 1889 ), dove compare una
giovane donna intenta a pettinarsi davanti allo specchio. Il quadro
individua un gesto legato alla sfera del corpo, come accade nelle
numerose serie di donne al bagno,
che toccano temi decisamente estranei alla cultura figurativa
occidentale, ma non sconosciuti all'arte orientale.
 dcr
dcr
E. Degas, Donna con i crisantemi, 1865

E. Degas, Hortense Valpincon, 1871
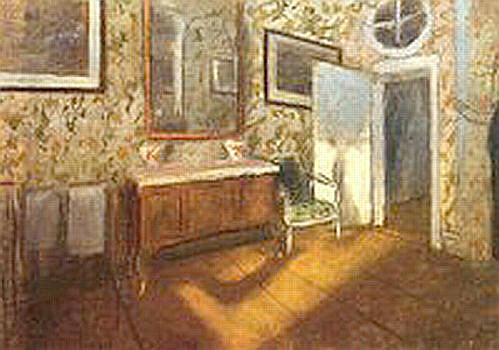 I
I
E. Degas, Interno presso Menil-Hubert, 1880 ca.

E. Degas, Davanti allo specchio, 1889
● I riti della vita familiare e l'estraneitÓ della coppia
L'immagine che
Degas ci
dipinge della coppia non Ŕ serena ed il luogo che ospita la vita
dei coniugi spesso assume i contorni di uno
spazio chiuso,
inibente, impenetrabile dall'esterno e privo di vie di fuga, tutto
immerso in atmosfere di preoccupata incomunicabilitÓ. Gli interni di
Degas sono
prigioni piene di inquietudini.
La sua predilezione per la rappresentazione degli interni,
illuminati trasversalmente da una fonte di luce invisibile che esalta
solo i suoi effetti di rifrazione sulla figura umana (
Madame Camus, 1870 ), porta a racchiudere i soggetti in
nicchie d'azione anguste e immutabili. Le ballerine sono destinate
allo spazio ristretto del palcoscenico,
della sala per gli esercizi; le modelle si
muovono nell'angolo di un bagno;
le prostitute per definizione vivono in "case
chiuse"; le signore borghesi sono
prigioniere di abiti accollati
o stanze segnate da strisce di colore che sono
sbarre ingigantite.
La gabbia pi¨ atroce Ŕ quella della casa in cui si muove la coppia.
Gli intemi di Degas
manifestano una tensione verso
l'indagine del "non visibile" assolutamente moderna. Una prima
eccentricitÓ Ŕ data dai punti di vista obliqui, o
esageratamente alti e bassi, che costringono alla deformazione
anche un corpo perfetto come quello di una ballerina. Anche quando lo spazio
non Ŕ rappresentato attraverso una prospettiva eccentrica, esso appare
artificialmente dilatato a suggerire un "non visibile" in interni
mentalmente aperti che lasciano intravedere la realtÓ pi¨ profonda
delle persone che li abitano.
Moltre delle atmosfere di Degas rinviano alla moderna pittura di interni di
Edward Hopper
( da G. Mori, Degas tra antico e moderno, Art e dossier n.204,
Giunti 2004 )

E. Degas, La famiglia Bellelli, 1858-67

E. Degas, Ritratto dei coniugi Morbilli, 1867

E. Degas, Ritratto di Manet con la moglie, 1868
- 1869
 MC
MC
E. Degas, Madame Camus in rosso con ventaglio,
1870
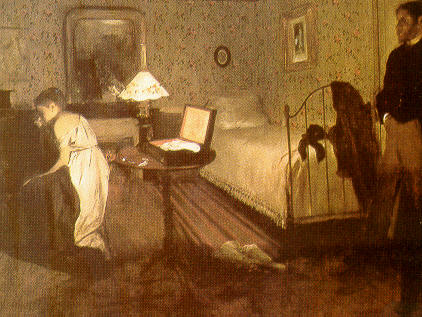
E. Degas, Interieur - Le viol, ( Lo stupro ), 1868 - 1869
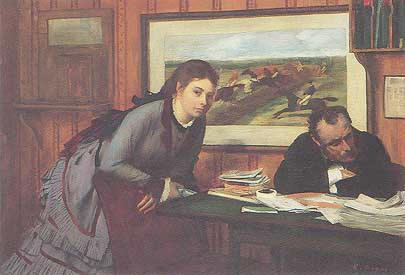 br
br
E. Degas, Il broncio, 1869 - 1871
●
L'oggettiva fissitÓ del quotidiano
Sulla Camera da letto, la tela del 1888, cosý scrisse
Van Gogh a
Gauguin:
"Ho fatto, sempre per uso mio, un quadro largo 30 della mia camera
da letto, con i mobili di legno che conoscete. Ebbene, mi ha enormemente
divertito fare questo interno senza nulla, con una semplicitÓ alla Seurat.
A tinte piatte ma stese grossolanamente, a pieno impasto, i muri di un lilla
pallido, il pavimento di un rosso spezzato e stinto, le sedie e il letto
giallo cromo, i cuscini e il lenzuolo di un verde limone molto pallido, la
coperta rosso sangue, la toeletta arancione, il catino blu, la finestra
verde. Avrei voluto esprimere un assoluto riposo con tutti questi toni
cosý diversi, lo vedete, e in cui di bianco non c'Ŕ che la piccola nota data
dallo specchio con la cornice nera ...".
E al fratello ThÚo:
"Il colore qui deve creare la cosa e, dando, con la sua semplificazione,
un pi¨ alto stile alle cose, suggerire il riposo o il sonno in generale. Insomma, la vista del quadro deve riposare la testa o piuttosto
l'immaginazione. ( ... ) vedi come Ŕ semplice la concezione. Ombre e ombre
proiettate sono soppresse, Ŕ colorato a tinte piatte e decise come le stoffe
dipinte".
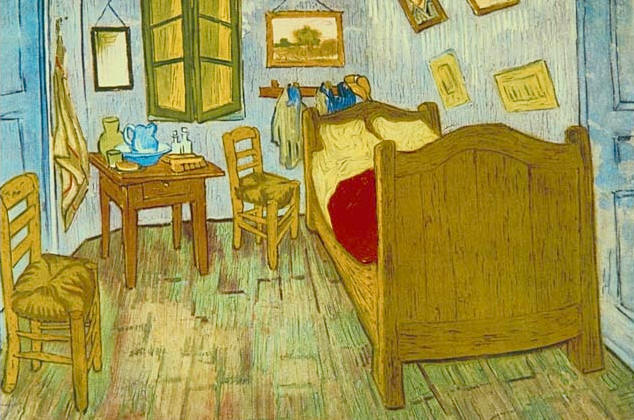
V. Van Gogh, La camera da letto, 1888
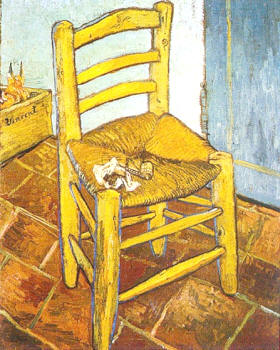 se
se
V. Van Gogh, La sedia di Van Gogh,1888

V. Van Gogh, Interno di un ristorante, 1887
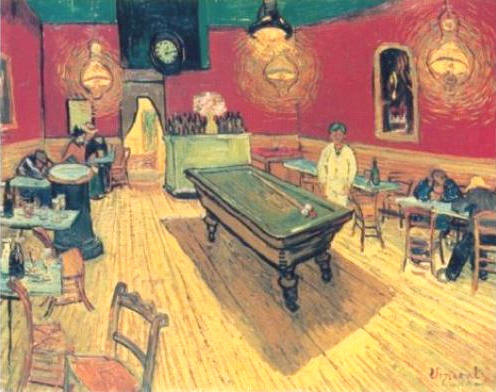
V. Van Gogh, CaffÚ di notte, 1888
Evidenza volumetrica e solida compattezza assumono gli oggetti
nella loro struttura prevalentemente cromatica. La visione degli
interni di Cezanne
appare del tutto nuova ed autonoma rispetto a quella degli impressionisti e
dello stesso Degas. Egli usa la luce ed il colore per costruire le
forme, che, attraverso una sintetica semplificazione delle linee di
contorno, sono ridotte ai termini essenziali.
Si creano nel contempo complesse strutture compositive dei vari elementi,
che danno vita a ordinate disposizioni geometriche, dotate di
inusitato ritmo ascensionale per una natura morta.
Sul piano dei significati tale ricerca di assoluta stabilitÓ dei piani
esalta il valore strutturante dell'intera composizione. Esso
suggerisce all'osservatore la continua rivisitazione dei piani visivi e
delle prospettive della realtÓ, anche di quelle che tendiamo a considerare a
noi pi¨ familiari.
 nm
nm
P. CÚzanne - Natura morta con bottiglia di
liquore alla menta - 1890-1894

P. CÚzanne - Tenda, caraffa e piatti con frutta,
1895
● Emblemi della dimensione domestica

E. Degas, Ritratto di Hilaire Degas, 1857

P. CÚzanne, Madame CÚzanne nella poltrona
gialla, 1890 - 94

P. CÚzanne, Madame CÚzanne nella poltrona rossa, 1877

P. CÚzanne, Donna con caffettiera, 1895